#3.10 Vergogna e gioco

Qualche anno fa un fotografo mi fece notare che “tanto a te non ti si vede MAI in giro”. Così, a bruciapelo. Ricordo che era mattina presto. Le critiche ricevute subito dopo colazione sono quelle che rimangono più impresse, a quanto pare. La frecciata andò a segno. La presenza pubblica per chi fotografa, conta. Come? Quanto?
La metafora qui è quella della gara: esserci nel posto giusto, con i lavori giusti, con un certo modo di fare e via discorrendo. La fotografia è un settore molto competitivo dove i premi per cui vale la pena gareggiare sono pochi e i concorrenti sempre di più, forti e ambiziosi. Se la mettiamo così, cos’altro posso essere io, che mi ostino ad andare avanti con il mio passo, se non una perdente?
Facile: sono una persona che non vede la fotografia come una competizione.
Il che non fa sparire la pressione o la posta in gioco. C’è sempre da correre dietro a qualcosa (o via da qualcos’altro). Lavorare con la fotografia è un campo di battaglia.

Non partecipare alla gara è una decisione alla quale sono arrivata con il tempo. Non potrei esistere lì dentro come fotografa, crollerei dopo due minuti. In realtà non so nemmeno se posso considerarmi una perdente, l’ultima arrivata, se nella lista dei partecipanti non compaio.
Una volta, un bel po’ di tempo fa, ho declinato l’invito a partecipare a una cosa e un fotografo mi disse che mi stavo facendo scappare un’occasione ed ero un po’ vigliacca. Non sto esagerando i termini. Il fotografo non era lo stesso che non mi vedeva mai in giro, tanto per precisare.
A quanto pare la mia vita fotografica è costellata di occasioni lasciate andare e di gente che me lo fa notare. Pazienza. Continuo a investire il mio tempo come meglio ritengo. Cerco un modo personale per vivere la fotografia, con tutti i pro e contro. Perché magari di qui a due anni crolla tutto e finisco con l’allevare cani lupo cecoslovacchi. E allora sì che, davvero, non mi si vedrà più un giro.
Però, a voler essere proprio onesta, c’è una parte di me che incassa molto male queste osservazioni. Forse quella parte di me che ha indossato il costume da fotografa per farsi prendere sul serio e ora non riesce più a toglierselo. Perché ha paura, perché non sa, non capisce come funzionano le cose e quindi non ha il diritto di definire la propria strada. Non è neanche un granello di sabbia in un paesaggio di montagne inaccessibili e oceani tempestosi.
«E ora ho voglia di raccontarvi, signori, vi piaccia o non vi piaccia, perché io non sia riuscito a diventare nemmeno un insetto. Vi dichiaro solennemente che spesso desideravo diventare un insetto. Ma neppure di ciò ero degno». Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo. Edizione Kindle.
In psicologia ci sono tanti modelli1 che descrivono la natura molteplice e frammentata della nostra identità. Teorie che spiegano come tutti questi sé siano necessari per muoversi in armonia con le differenti situazioni sociali che incontriamo durante la nostra vita, come collaborano e come, a volte, entrano in conflitto: quello che siamo, quello che vorremmo essere e quello che gli altri si aspettano che siamo.
Le dinamiche tra le varie identità possono essere rappresentate con modelli generali, che spiegano molto, ma restano limitati perché non possono descrivere la dimensione soggettiva. Il significato, l’emozione, l’esperienza così come la vive il singolo individuo. L’unico modello di vita totale e completo di un essere vivente è quello che contiene l’insieme di tutte le vite possibili. Non è un’approssimazione, non è economico. È infinito e irrazionale.
Qualche volta lavorare con la fotografia mi crea dei problemi. Non il puro fotografare, quello mi piace sempre un sacco. Ho problemi con il “ruolo sociale”, per intenderci. In quei momenti è come se tutte le mie diverse identità si mettano a discutere. Mi sembra di stare in una stanza piena di gente dove torto e ragione si confondono. C’è una questione da risolvere ma non capisco più a chi dare retta e, alla fine, mi sembra solo di perdere la presa su tutti i miei punti fissi, che il senso delle cose si vada sgretolando.
Quando succede finisco per ripiegarmi su me stessa come un riccio. Un po’ perché mi piace stare per conto mio, ma un po’ anche perché mi vergogno. Qualche volta la vergogna dura per un po’, e diventa questo sentimento di sottofondo che condisce tutti gli aspetti delle mie giornate. Altre volte, invece, arriva come una fitta improvvisa per i motivi più inutili e fa male, così, per un po’.
La vergogna è un’emozione che causa un certo grado di sofferenza. È legata al rischio di compromettere la propria buona immagine o la capacità di fare qualcosa. Ci si può vergognare di qualsiasi “evento, proprietà e azione che permetta agli altri, o a noi stessi, di assumere su di noi una valutazione negativa”2. In poche parole: ci si può vergognare di qualsiasi cosa. Non ci si può nascondere.
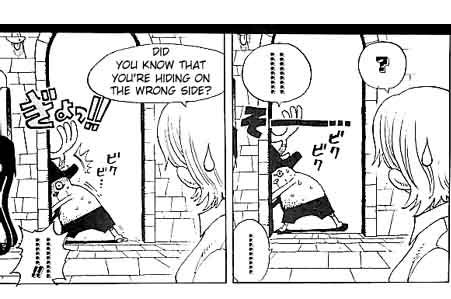
Secondo alcune classificazioni la vergogna sarebbe un’emozione secondaria che si apprende attraverso l’interazione sociale. Una volta interiorizzata, però, può anche manifestarsi senza la presenza di un’altra persona o di un pubblico (a differenza dell’imbarazzo). A volte basta che vi sia una norma, un riferimento, un valore riconosciuto e condiviso.
Come per tutte le altre emozioni c’è chi sostiene che la vergogna abbia anche una qualche funzione: quella di avvisare l’individuo quando sta compiendo azioni che potrebbero compromettere non solo la propria immagine, ma anche la posizione all’interno del gruppo sociale. La vergogna è un sistema di protezione, in un certo senso.
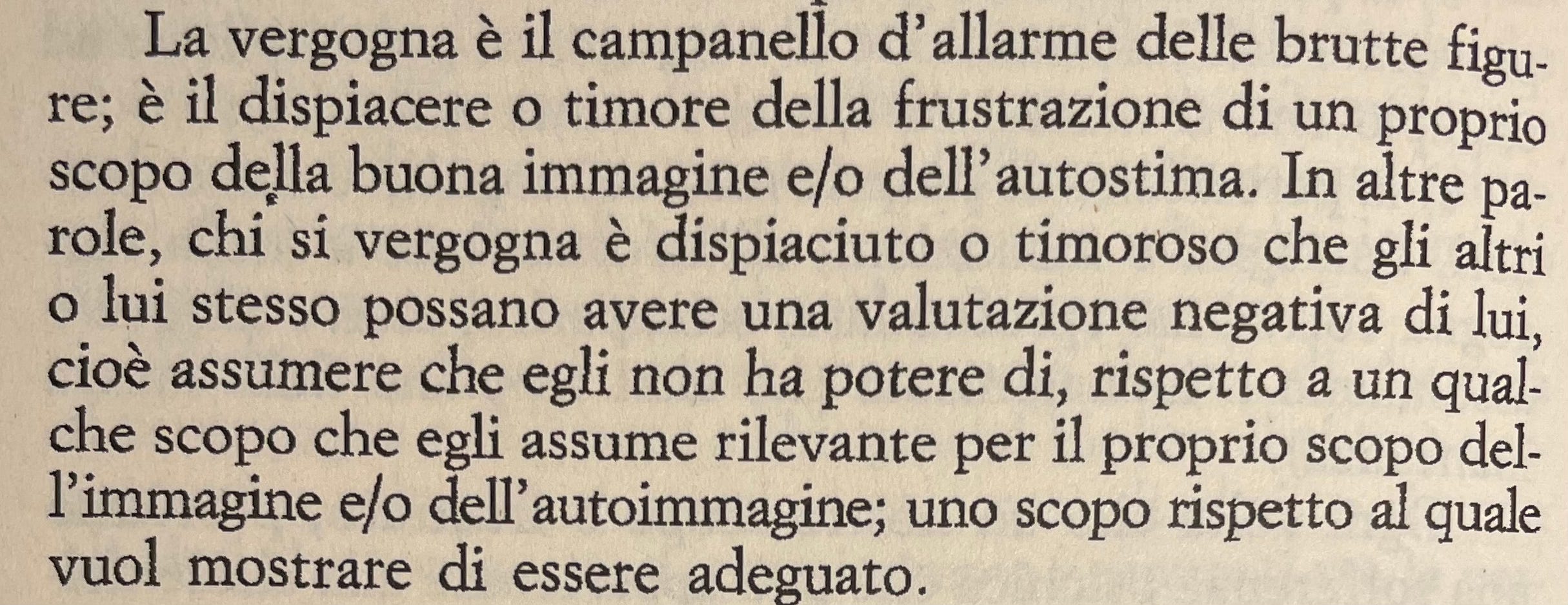
La vergogna è anche uno strumento di potere. In molte culture e gruppi sociali viene usata come forma di controllo, per modellare corpi, comportamenti e pensieri.
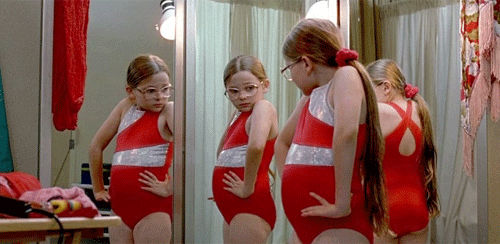
«It supports group norms and shapes individual and group behavior. At the group-level, however, the ethnocentric nature of shame and shaming can have serious consequences for individuals and societies, especially with the stigmatic form». Rodger A. Bates, Bryan LaBrecque, The Sociology of Shaming. The Journal of Public and Professional Sociology, 2020.
La vergogna, a volte, si lega all’umiliazione. E allora tanto vale che vada a scavarmi un buco aspettando che la tempesta passi.
«I am endowed by shame’s vast memory, more detailed and implacable than any other, a gift unique to shame». Annie Ernaux, A Girl’s Story. Edizione Kindle, 2020.
La vergogna è disconnessione. È (anche) così che si isolano le persone e si toglie loro potere.
«Shame is fundamentally disconnecting. The person feeling shame is often acutely aware of their own perceived flaws and inadequacies, and may misinterpret attempts from others to connect with them». ACT with compassion, Moving from shame to connection through play.

«In Greece, Ioanna tells us, “Shame on you” is an everyday feature of the language, and the emotion is used as moral framing that everyone is expected to live within». Laura Snoad, Photographer Ioanna Sakellaraki’s Aidos series explores the importance of shame in Greek culture. It’s Nice That, 2018.
La vergogna, in quanto emozione sociale, acquista tanta più forza grazie al contesto e all’importanza che noi diamo all’immagine di noi stessi e di quello che facciamo. In parole povere: più ce la sentiamo addosso, “nostra”, e più diventa forte. È potente anche perché, spesso, ci si vergogna anche solo a parlarne. Anche quello della fotografia è una dimensione di ruoli e gruppi sociali, di confini e barriere più o meno permeabili.
Qualche tempo fa, chiaccherando con un’amica, il discorso è caduto sulla separazione invisibile ma impenetrabile tra fotografia commerciale e autoriale, sulla sensazione di sentirsi poco credibili e capaci nella seconda quando si arriva dalla prima. Quasi come se l’una si vergognasse dell’altra (o viceversa). Alla fine è più facile tenere ben separate le due realtà anche quando c’è compenetrazione, quando si annodano dentro la stessa persona. E la cosa ha senso perché, ad esempio, alcuni flussi di lavoro e di comunicazione sono differenti. Però altre volte mi chiedo come sarebbe vedere le cose con un taglio più trasversale.
Più le cerchie si fanno piccole ed esclusive, più la vergogna può definire confini, chi può, o non può, fare qualcosa. Chi può essere o non esser qualcun*. È pensiero comune che per le pratiche creative sia necessario vivere un po’ fuori dagli schemi, lasciare da parte la vergogna. È vero.
«Embarrassment is important. If you’re not willing to humiliate yourself, make mistakes and downright fuck-up, you should consider working in a cubicle farm. It’s safer there. Because as a creative, you’ll be called an idiot at least once a day.
Making mistakes and risking embarrassment, even failure, is how you progress. Without it, you’ll be stuck in the same old safe zone: not embarrassed, but not better either. So if we want to do this thing we love, make stuff, we have to get over our need not to look stupid». KesselsKramer, The Embarassment Show.
La vergogna può bloccare l’azione creativa, d’altronde, un po’ è anche quello il suo compito! Fermati! Vorrai mica pubblicare quella cosa, o scrivere quell’altro. Ma allo stesso tempo: non stai facendo abbastanza, o non abbastanza bene.
E così alla fine della giornata viene solo voglia di scavarsi un buco e metterci una pietra sopra (o chiudersi a riccio).
«I am ashamed of myself. I ought to have written to you before, but the fact is I have not written anything at all.
[...] I sit down religiously every morning, I sit down for eight hours every day and the sitting down is all. In the course of that working day of 8 hours I write 3 sentences which I erase before leaving the table in despair.
[…] I ask myself sometimes whether I am bewitched, whether I am the victim of an evil eye? But there is no “jettatura” in England is there? I assure you speaking soberly and on my word of honour that sometimes it takes all my resolution and power of self control to refrain from butting my head against the wall. I want to howl and foam at the mouth but I daren’t do it for fear of waking that baby and alarming my wife. It’s no joking matter. After such crises of despair I doze for hours still half conscious that there is that story I am unable to write. Then I wake up, try again and at last go to bed completely done-up. So the days pass and nothing is done. At night I sleep. In the morning I get up with the horror of that powerlessness I must face through a day of vain efforts.
[…] You know how bad it is when one feels one’s liver, or lungs. Well I feel my brain. I am distinctly conscious of the contents of my head. My story is there in a fluid in an evading shape. I can’t get hold of it. It is all there to bursting, yet I can’t get hold of it no more than you can grasp a handful of water». Joseph Conrad edited by Laurence Davies, The Collected Letters of Joseph Conrad.
Non rimuginare troppo, mettersi al lavoro, aiuta a superare il blocco (non so se Joseph Conrad sarebbe d’accordo, però). Fare lontano da un pubblico, sospendere il nostro stesso giudizio, tanto è tutto lavoro che nessuno vedrà mai3.
«Very few writers really know what they are doing until they’ve done it. Nor do they go about their business feeling dewy and thrilled. They do not type a few stiff warm-up sentences and then find themselves bounding along like huskies across the snow.
[…]
For me and most of the other writers I know, writing is not rapturous. In fact, the only way I can get anything written at all is to write really, really shitty first drafts». Anne Lamott, Shitty First Drafts da Bird by Bird. Some Instructions on Writing and Life. Edizione Kindle, 2007.
Quindi si tratta di fare e accettare qualsiasi cosa esca, anche se si tratta solo di scarti. Ma anche: vivere questo tempo di esitazione, questo limbo, come parte del processo.
«“In teoria, mi piacerebbe molto lavorare tutti i giorni”, affermò lo scrittore. “Ma la mattina invento ogni scusa possibile per non lavorare, che devo uscire, fare acquisti, comprare il giornale. In linea di massima, alla fine spreco la mattinata e finisco per sedermi a scrivere di pomeriggio. Sono uno scrittore diurno, ma poiché spreco le mie mattine, sono diventato uno scrittore pomeridiano. Potrei scrivere di sera, ma quando lo faccio, poi non dormo. Quindi, cerco di evitarlo”.
Nella stessa intervista, Calvino ammise di essere uno scrittore non soltanto pomeridiano, ma tardo-pomeridiano. Anche quando si sforzava e riusciva a sedersi alla scrivania, all’inizio doveva occuparsi delle lettere inevase che ogni volta immancabilmente lo attendevano. Poi riscriveva il lavoro del giorno precedente, dedicando a questa attività una buona parte del tempo che gli rimaneva per scrivere. Quando finalmente cominciava a scrivere cose nuove, lo faceva a rilento, correggendo in continuazione: faceva talmente tante revisioni e aggiunte che alla fine a volte non riusciva più a decifrare le pagine». Mason Currey, Italo Calvino in Rituali quotidiani. Vallardi, Edizione Kindle, 2016.
Ricapitoliamo: la vergogna è un’emozione sociale che può aiutarci a “salvare la faccia”, ma è anche un ostacolo all’azione creativa. Perciò prima ce ne liberiamo, meglio è.
Giusto. Però…
…c’è anche chi pensa che la vergogna, in alcuni contesti, non solo non blocca la creatività ma, addirittura, la alimenta4. Il discorso, in due parole, è questo: un certo evento minaccia la mia immagine, mi sento male per la vergogna. Per recuperare e dimostrare di essere migliore mi impegno di più e trovo soluzioni creative in modo da uscirne bene.
Può essere.
Diciamo che con le condizioni giuste, in un ambiente supportivo e con un po’ di spazio di azione, possiamo riuscire a infilarci un revenge dress e capovolgere la situazione.

Ma non ci fermiamo qui!
C’è chi sostiene che la vergogna sia anche uno strumento rivoluzionario. Nel momento in cui il suo potere viene preso e rimbalzato verso la sorgente diventa “la molla di una disobbedienza coraggiosa”5.
«Ma quello che viene fuori dal libro di Gros è il potere della vergogna come strumento rivoluzionario, come motore di riscatto sociale, ad esempio. Se prima chi si vergognava per lo stupro era la vittima, dice Gros, ora il paradigma sta cambiando, “cambiando campo la vergogna cambia anche natura: non è più l’angoscia per qualcosa d’innominabile che mi accade, bensì la proclamazione pubblica dell’ignominia dell’aggressore”.
[…] la vergogna si è trasformata in qualcosa di estremamente tangibile […] realizzandosi nell’estromissione dei colpevoli dai loro ruoli di potere […]». Giulio Silvano, Come è cambiata la vergogna. Esquire, 2023.
I paradigmi staranno mutando, ma “cambiare” la vergogna non è un’operazione facile. Ci vogliono le condizioni giuste per sublimarla. Ci vuole uno spazio sicuro dove il giudizio possa essere sospeso, dove i poteri non agiscono in maniera forte. Una sandbox. Ci vuole lo spazio del gioco per prendere qualcosa e rispedirla indietro con un carico di significati del tutto nuovo.

Esistono alcune dimensioni sospese dallo spazio normativo quotidiano in cui le persone possono rimaneggiare significati e regole. In cui si può fare quello che “di solito” non è consentito e, a volte, quello che facciamo lì dentro può influenzare il sistema esterno. È un po’ come tirare fuori un pezzetto di codice dal programma generale, modificarlo e poi rimetterlo in moto.
Il gioco è uno di questi spazi, così come anche l’arte. Il sogno, il sottosuolo, lo spazio dove 2+2=5. Sgretolare il senso delle cose, ma di quelle che non vanno, che non servono più, senza vergogna.
«Le rispettabilissime formiche cominciano dal formicaio e finiscono sicuramente con il formicaio. E questo fa un grande onore alla loro costanza e positività. Ma l’uomo, essere leggero e deplorevole, e forse simile al giocatore di scacchi, ama solo il perseguimento dello scopo, non lo scopo. E chi lo sa (garantirlo è impossibile), magari tutto lo scopo dell’esistenza cui l’umanità aspira si racchiude nell’inestinguibilità del perseguimento dello scopo, o per dirla in altro modo, nella vita e non nello scopo, che s’intende, dev’essere nient’altro che due-per-due-quattro, cioè una formula, ma due-per-due, signori, non è già più vita, è piuttosto l’inizio della morte.
[…] Poniamo, l’uomo non fa che cercare questo due-per-due-quattro, attraversa gli oceani, sacrifica la vita a questa ricerca, ma un conto è ricercare, e un altro è trovare davvero: questo perdio gli fa paura. Perché sente che quando avrà trovato non avrà più niente da cercare. I lavoratori quando hanno terminato il lavoro ricevono perlomeno i soldi, vanno all’osteria, poi finiscono in questura, e insomma sono occupati ancora per una settimana. Ma l’uomo dove andrà? Quanto meno si nota in lui un certo imbarazzo ogni volta che raggiunge simili scopi. Il raggiungimento gli piace ma non definitivo, e questo, naturalmente, è spaventosamente ridicolo. Insomma la natura umana è proprio comica […]. Ma il due-per-due-quattro è comunque una faccenda spregevole. Due-per-due-quattro secondo me è solo una impudenza. Il due-per-due-quattro vi guarda con insolenza, si piazza sul vostro cammino con le mani sui fianchi, e sputa6. Sono d’accordo, questo due-per-due-quattro è una cosa esemplare; ma se c’è da lodare, allora anche due-per-due-cinque qualche volta è una chicca». Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo. Edizione Kindle.
Oggi le ricerche intorno alla dimensione psicologica del gioco sono sempre di più, ma per molto tempo è stato considerato un argomento marginale, di interesse secondario, per cui c’è ancora molto da scoprire.
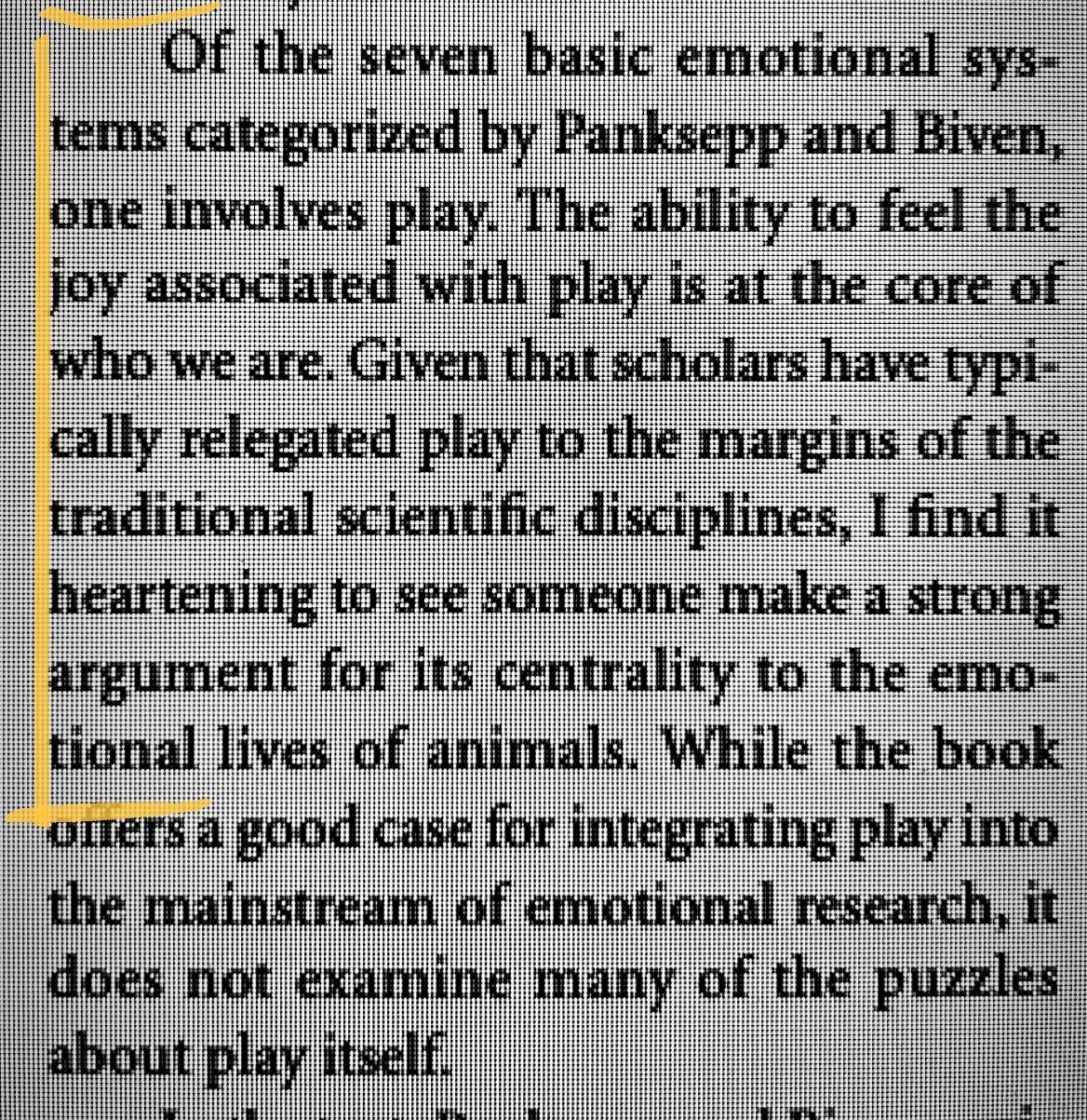
Secondo Donald Winnicott il gioco è un’area di esperienza a cavallo tra la realtà soggettiva, propria dell’individuo, e quella oggettiva. Si tratta dell’esperienza transizionale, o spazio potenziale. Winnicott si occupava di sviluppo e infanzia, e sto anche semplificando molto le cose per arrivare al punto in cui arriviamo alla fotografia, ma il discorso tiene (e comunque c’è sempre internet per approfondire quanto volete).
«The child invests the object with something of his or her own inner experience so that it is both an object in the outer world and part of his or her inner personal world at the same time. Winnicott thought that we all need this intermediate area of experiencing which he called potential or transitional space. Older children access it through play, and as adults we can find it in a number of experiences including religion and the arts.
[…]
In creating a new body of work, photographers not only relate to elements of the outside world (the subject of the photographs, the camera, the prints and so on), but they also embark on a personal journey, which in turn will reflect some aspect of their inner world». Patricia Townsend, Between Inner and Outer Worlds in Photographers and Research: the role of research in contemporary photographic practice. Shirley Read and Mike Simmons, 2017.
Nel gioco possiamo rinegoziare ruoli e significati. Ci sono giochi che possono diventare competizioni ma, di base, lo spazio potenziale è il luogo di rimestamento delle possibilità, non quello dove si decide chi vince o chi perde. Non c’è uno scopo finale da raggiungere, un premio da vincere, quanto, piuttosto, riuscire a continuare a giocare fino a che ne abbiamo voglia.
«Bene o male, mandare in frantumi ogni tanto qualcosa è pure molto piacevole. Io non è che sostengo i valori della sofferenza, ma neanche quelli del benessere. Io mi batto…per il capriccio, e per la garanzia che mi sia garantito, quando ne avrò voglia». Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo. Edizione Kindle.
Nella fotografia esistono spazi e occasioni di competizione. Ci sono giudizi che possono causare vergogna. Le parole che feriscono e che ci bloccano sono il due-per-due-quattro, il fischio dell’arbitro che segna la fine del gioco. È un’imposizione, una forzatura che ci dice di fermarci finché siamo ancora in tempo, finché non abbiamo perso del tutto la faccia (ma quale faccia? Quale maschera sociale?)
Il creare immagini avviene prima di tutto nella dimensione del gioco, non in quella della misura. La fotografia come gioco è una pratica che serve a sprogrammare il programma, a far prendere aria, a dare tempo all’anima di raggiungerci.
«La fotografia è desiderio di conoscenza, non capire quanto piuttosto di comprendere. “Comprendere” è una parola italiana che si usa poco, che vuol dire “far parte” e per far parte non puoi stare lì a guardare soltanto; fotografare è un modo per guardare di più e più intensamente, per insistere con lo sguardo
[…]
Ricordo di quando ero bambino o ragazzetto, camminavo a testa bassa, vergognandomi e guardandomi i piedi e, a volte, sbattevo contro i pali. La fotografia mi ha aiutato moltissimo a camminare non a testa bassa, mi ha insegnato a guardare dritto, non troppo in alto, non troppo in basso». A cura di Gabriella Gilli e Sara Guerrini, Guido Guidi intervistato da Serena Calò in Oltre l’immagine. Inconscio e fotografia. Postcart, 2015.

Un approfondimento tra tanti: le teorie di Hazel Markus e Ann Ruvolo. ↩
Cristiano Castelfranchi, Che figura. Emozioni e immagine sociale. Il Mulino, 2017. ↩
Questo non vale per Roland Barthes che muore per un incidente mentre sta preparando il testo Non si riesce mai a parlare di ciò che si ama. Solo la prima pagina era terminata (forse), la seconda era ancora nella macchina da scrivere. Eppure c’è chi ha avuto la “prontezza” di pubblicare tutto dopo la sua morte. La lezione qui è: se state lavorando qualcosa che il mondo non dovrà mai vedere, nascondetelo bene prima di uscire di casa (o lasciate un appunto). ↩
Helena V. González-Gómez, Andreas W. Richter, Turning shame into creativity: The importance of exposure to creative team environments. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Volume 126, 2015. ↩
Frédéric Gros, La vergogna è un sentimento rivoluzionario. Nottetempo, 2023. ↩
«Dopo il due-per-due, si capisce, non resta più niente da fare, ma neanche da sapere». Fëdor Michajlovič Dostoevskij, Memorie dal sottosuolo. Edizione Kindle. ↩
No spam, no sharing to third party. Only you and me.






