#3.4 La sindrome dell'impostore

La settimana scorsa ero a Torino per degli impegni e, tra una cosa e l’altra, mi ritrovo con un po’ di tempo libero per le mani. Non così tanto da andare a visitare qualcosa, ma abbastanza per un gelato e un giro sotto i portici. Sprecare un’occasione per godersi la vita in un bel pomeriggio primaverile non è un peccato mortale, di più.
Entro in una grossa libreria e prendo a gironzolare tra gli scaffali finché non vado a sbattere contro un muro: la parete dedicata alla psicologia. È impossibile evitarla, è proprio in mezzo alla sala, uno spartiacque tra la sezione storia-geopolitica-scienza e quella della letteratura per l’infanzia. Non si può mancare, cioè, ad un certo punto devi decidere se andare da una parte o dall’altra, buttarti nella vita dei grandi o ritirarti nel mondo della fantasia. In mezzo ci trovi la psicologia, a fare da guardiana tra il mondo della ricerca scientifica e quello dell’immaginazione. Il che è abbastanza appropriato, a pensarci bene.
Per me questo guardiano ha un volto, ed è quello di Gustav Theodor Fechner:

Ci tenevo a presentarvelo perché è uno dei personaggi della storia della psicologia che più mi sta simpatico. Si dedica alla fisica per buona parte della sua vita, fino a quando non perde quasi del tutto la vista fissando il sole per il bene della ricerca. Non potendo più dedicarsi alla sua disciplina (nel 1800 non è che la fisica avesse chissà quali strumentazioni per analizzare i fenomeni, e quelle fornite “di serie” con lo scienziato erano molto importanti) comincia a dedicarsi alla filosofia, alle culture orientali e alla psicologia. Diventa uno studioso multidisciplinare.
È noto per essere il padre della psicofisica e l’inventore di un’equazione che mette in relazione anima e materia. Che a scriverne ora sembra una cosa da letteratura fantasy, ma all’epoca è stata una bella rivoluzione. Nella lotta tra idealisti e materialisti, per cui o esisteva SOLO la realtà delle idee, che noi stess* costruiamo, o SOLO la realtà oggettiva della materia, arriva questo fisico mancato che dice “sai che c’è? Magari anima e materia sono solo due facce della stessa medaglia”. E trova un modo per dimostrarlo. Zitto zitto, il buon Gustav traccia la sua strada e quella degli studi successivi.
Torniamo alla libreria. Gli scaffali di psicologia sono dei luoghi temibilissimi. Sono come delle foreste intricate dove è molto facile perdersi e farsi male. Fianco a fianco convivono manuali e strumenti tecnici che si possono solo mal interpretare senza una certa formazione1 e libri, che, detta brutalmente, non vanno bene nemmeno per accendere la stufa. C’è molto materiale valido e utile, certo, ma credo che, in generale, ancora manchino i riferimenti (culturali, di esperienza, sociali) per navigare tutta questa conoscenza. Magari un domani non sarà più così, lo spero, ma per il momento io mi ci avvicino con cautela. Ci sono nozioni che sono allo stesso tempo utili e dannose se inquadrate in una o nell’altra prospettiva. Ci sono concetti che sono estremamente specifici ma riduttivi, per cui possono essere molto validi in alcune situazioni ma in altre no. Poi ci sono anche quelle che sembrano verità assolute, psicologia e buon senso a volte si sovrappongono, ma ci sono casi in cui è importante metterle in dubbio.
Ci sono anche le aspettative che le persone (giustamente) si creano nei confronti delle nozioni psicologiche con cui entrano in contatto, perché esistono molti campi di applicazione (clinico, prevenzione, empowerment ma anche manipolazione, controllo e discriminazione) e gli stessi strumenti possono essere usati sia per fare del bene che del male. Come un martello.
Diffondere le nozioni psicologiche ha senso, perché la conoscenza ha funzione emancipatoria e permette alle persone di elaborare una propria comprensione e interpretazione del mondo, per evitare di subire certi fenomeni o, peggio, di finire vittima di specifiche dinamiche. Alcune di queste spiegazioni vanno toccare nervi scoperti. Colmano lacune dei “sistemi di riferimento”, che siano le istituzioni o la famiglia. Diventano popolari perché rispondono a bisogni specifici di molte persone, le aiutano a dare un nome a certe esperienze e a sentirsi meno sole. Le fanno proprie perché, in qualche modo spiegano e confortano.
«I would traverse not once more, but often the hell of my inner being. One day I would be a better hand at the game. One day I would learn how to laugh». Herman Hesse, Steppenwolf. Penguin Modern Classics (Edizione Kindle), 2012.
Ma, dall’altro lato, sappiamo tutti che, per come girano le notizie oggi, c’è il rischio che le informazioni si trasformino in assunti semplificati, spiegazioni decontestualizzate, ma legittimate da una sorta di pseudo-scientificità o autorevolezza senza fondamenta. Che vengano prese per buone e basta e diventino atteggiamenti, modi di fare, di giudicare e giustificare comportamenti.
Una volta che una spiegazione raggiunge questo grado di popolarità è difficile riparlarne e metterla in discussione, perché per tutti “è così”. Si rinforza continuamente e bisogna ripercorrere tutta la storia fino alle origini, con il lanternino, per andare a scoprire gli aspetti che sono passati inosservati. Succede anche nel campo della ricerca scientifica, non è solo una questione di superficialità.
Tutta questa introduzione per arrivare a parlare della sindrome dell’impostore. Sono tante parole, lo so, ma mi servivano. È un argomento così comune tra fotograf* e creativ* che se l’avessi buttato lì subito dopo il titolo, la prima reazione sarebbe stata “Sì, la so! Questo, quello e quell’altro”. Ci piace rispondere bene, ci rinforzano per anni a farlo.

Ma proprio perché è un argomento così comune volevo che ci arrivaste non troppo legat* a tutto quello che sapete già (anche se probabilmente va bene). Perché dobbiamo ripartire da zero e allargare un po’ la prospettiva.
«Everyone has experienced some, if not all of these truths along the way, even the professionals, but people rarely talk about it—hence, feeling alone. I feel totally fine about being self-taught now, but for a long time I didn’t. I have embraced my nontraditional path (starting later in life, being self-taught), but at first I felt like an imposter. I have come to learn there is a term for that, Imposter Syndrome, and people from every field experience it. We think that despite our success we are just lucky or that we have deceived people somehow to believe our work is worthwhile.
[…]
I felt like an imposter even after my work became well-known and was selling and I had a long roster of illustration clients». Danielle Krysa e Martha Rich (Illustrazioni), Your Inner Critic Is a Big Jerk: And Other Truths About Being Creative. Chronicle Books Llc, 2016.

La sindrome dell'impostore descrive la sensazione persistente di svalutazione e dubbio verso sé stess* e le proprie capacità, nonostante i risultati ottenuti, spesso con la paura di essere smascherati2. È un fenomeno di cui si parla in fotografia, ma anche in tutti i campi creativi e non. Ci sono ricerche che coinvolgono studenti STEMM3, medici e professionist* di molte categorie diverse, soprattutto a livelli di specializzazione e competizione molto alti.
La definizione di sindrome dell’impostore raccoglie un insieme eterogeneo di vissuti che sono stati osservati in diverse persone e descritti con vari nomi. Il termine specifico che conosciamo oggi deriva da uno studio del 1978 di due psicologhe, Pauline Rose Clance e Suzanne Imes: The Imposter Phenomenon in High Achieving Women: Dynamics and Therapeutic Intervention.
La narrativa attuale intorno alla sindrome dell’impostore la vede come una condizione che riguarda prima di tutto l’individuo che ne fa esperienza, e cosa può fare per combatterla. Viene indirettamente associata alla sfera semantica della malattia mentale (anche se non esiste nelle classificazioni dei manuali diagnostici). Si riconosce una certa influenza di specifici contesti sociali, come ambiti professionali estremamente competitivi o l’appartenere a una minoranza, ma è come se questi facessero solo da sfondo a qualcosa che è responsabilità dell’individuo. La definizione stessa di “sindrome” implica che sia un insieme di sintomi e fattori, una condizione individuale, un’interpretazione depoliticizzata-individualizzata-universalizzata4.
«But eventually I wised up, and decided that this way of thinking was not productive and complete bullshit. And I am happy to say I do not feel like an imposter anymore. I value my self-taught-ness now. I see that it has allowed me so much freedom from feeling restricted by or scared of breaking “rules” that exist in the world of art and illustration. It has benefited me greatly!». Danielle Krysa e Martha Rich (Illustrazioni), Your Inner Critic Is a Big Jerk: And Other Truths About Being Creative. Chronicle Books Llc, 2016.
«I cannot remove self-doubt and I cannot make you feel that you are not an imposter if you feel that you are […]. However, I can suggest that it doesn’t matter how you feel as even though you may have that feeling, or hear those internal voices, you don’t have to listen to them. You know what you have done and what and who you are, the judgement of others is an opinion and not fact.
Don’t forget that the only way to stop feeling like an impostor is to stop thinking like an impostor, and that is something you could definitely start work on». Grant Scott, I’m a Photographer! The Imposter Syndrome and Photography. The United Nations of Photography, 2021.
Ho preso due esempi, ma ne possiamo cercare quanti ne vogliamo, l’attenzione è concentrata tutta sull’individuo. Sovrastimiamo il nostro potere, creando una sorta di illusione di controllo assoluto (e chi non ha bisogno di sentire che le cose sono sotto controllo, di questi tempi?). Quella del “self-made man”, l’uomo che si fa da sé, è una prospettiva ingenua e vecchia, anche se continua a resistere per motivi storici, politici e di mercato, in certi strati della cultura statunitense. Quella che spesso arriva da noi in maniera più “forte”.
Fare esperienza di un qualcosa, vederne gli effetti sulle nostre emozioni e vissuti, non implica necessariamente che ne siamo noi la fonte. A volte siamo un tramite per qualcos’altro, che magari subiamo o amplifichiamo. Possiamo imparare a modularne gli effetti, rafforzando quelle parti di noi che ci fanno sentire bene, forti, orgoglios*. Un po’ come prendermi cura di corpo e sistema immunitario prima di ogni cambio stagione. Posso applicare tutta una serie di strategie, integratori e barriere che mi permettono di stare bene e andare avanti con la mia vita. Ma nulla mi assicura l’immunità assoluta dall’influenza. Le cause sono fuori dal mio controllo, anche se i sintomi li vivo sulla mia pelle. Questo vale sia per i virus che per molte esperienze psicologiche.

«A Google search yields more than 5 million results and shows solutions ranging from attending conferences to reading books to reciting one’s accomplishments in front of a mirror. What’s less explored is why imposter syndrome exists in the first place […]». Ruchika Tulshyan e Jodi-Ann Burey, Stop Telling Women They Have Imposter Syndrome. Harvard Business Review, 2021.
La sindrome dell’impostore vive in tempi e luoghi specifici che sono al di fuori del, ma in relazione con, l’individuo, soprattutto in contesti molto competitivi. Culture dove si valorizzano, al limite del mito, comportamenti e soggetti eroici, che superano i propri limiti, compiendo atti straordinari.
«Imposter feelings are not ‘in’ people; they are produced by the dynamic between people and social contexts». Órla Meadhbh Murray, Yuan-Li Tiffany Chiu, Billy Wong e Jo Horsburgh, Deindividualising Imposter Syndrome: Imposter Work among Marginalised STEMM Undergraduates in the UK. Sociology, ottobre 2022.
La fotografia è una pratica individuale e competitiva. Cioè, non è solo, così. Sappiamo tutti che moltissime immagini (probabilmente la maggior parte) sono il risultato di una collaborazione tra fotograf*, o fotograf* e persone coinvolte in altri settori. Ma è anche così, la percezione è quella. Nel momento in cui mettiamo il piedino nella fotografia e cominciamo a definirci fotograf* con il resto del mondo, ci arriva addosso tutto questo carico di aspettative e prestazioni, anche se non lo vogliamo. Ci sono quelli che sono i Maestri della fotografia, i concorsi, le fotografie che devono emergere e venire pubblicate. Il contenuto che viene misurato in numeri e metriche sociali che vent’anni fa nemmeno esistevano e fra vent’anni chi lo sa. Il “mio cugino è stato pubblicato di qui e di là”. Si, va bene, ma io volevo solo chiederti un parere su questa immagine. Poi c’è la competizione con noi stess*, la rincorsa al miglioramento continuo o gli sforzi per convincere che andiamo bene così, la “minaccia” delle nuove tecnologie malcoprese e usate impropriamente.
Mi stanco solo a scriverne, ma lasciatemi fotografare in pace. Forse è per questo che molte persone che utilizzano la fotografia nelle lore pratiche non vogliono a tutti i costi definirsi fotograf*? Per evitare il peso che questa etichetta si porta dietro?

Il fatto che solo ora si cominci a vedere la sindrome dell’impostore anche come un fenomeno sociale non è per ignoranza, ma perché, piano piano, le prospettive si stanno arricchendo. Ed esitono anche molti più strumenti che facilitano l’osservazione e lo studio dei fenomeni sociali.
C’è poi anche un altro fattore da considerare. Oltre all’influenza della cultura iper-individualista, uno dei motivi per cui nella nostra società si tende a dare tutto questo peso all’individuo è che quando qualcosa non funziona è molto più semplice ed economico intervenire sui singoli, fare in modo che facciano loro il lavoro, che cambiare un intero sistema. Questo succede a tutti i livelli. Per un’organizzazione, per esempio, è molto più fattibile offrire formazione su tecniche di gestione del tempo e dello stress, o figure e bonus per il benessere, che andare a intervenire a monte (su orari di lavoro e compiti, per esempio).

Spesso le aree problematiche non sono nemmeno ben chiare. Ma questo non può diventare una giustificazione, perché se mai si inizia…

Se da un lato, in genere, le persone possono trovare delle strategie per adattarsi e prosperare anche in situazioni poco favorevoli, per non dire minacciose, dall’altro la prospettiva attuale della sindrome dell’impostore può portare a sensi di colpa e ad altre conseguenze poco piacevoli.
«Life is always frightful. We cannot help it and we are responsible all the same. One’s born and at once one is guilty». Herman Hesse, Steppenwolf. Penguin Modern Classics (Edizione Kindle), 2012.
Il “mettere a tacere” le voci interne può ridurre gli effetti negativi, certo, ma è anche un modo per svalutare e delegittimizzare il proprio sentire. Forse ci illudiamo di poter silenziare selettivamente le voci negative, ma non funziona così, non con questi metodi e non facendo da soli. È impossibile intervenire su una componente del nostro sentire, o della nostra personalità, con tale precisione da non intaccare anche tutto il resto: la motivazione, il riuscire a mettersi in dubbio, a conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti, al capirsi e vedersi in sé e in relazione con il resto del mondo. Ci sono tante caratteristiche positive che rischiano di finire limate insieme al resto.
Faccio una precisazione: con legittimare il proprio sentire non voglio che passi l’idea che se sento così, allora va bene tutto, perché il “va bene tutto” di rado equivale al pensiero critico e alla consapevolezza. Io sono una persona ottimista e ho tanta fiducia nelle risorse degli esseri viventi, ma ho quasi quarant’anni e non sono ingenua e le vedo le porcate che a volte il “io sento così” scarica nella fotografia e nel mondo. Le dinamiche di potere, le possibilità e gli abusi. Sentire e comportamento sono due cose diverse, il primo non può diventare una giustificazione del secondo. Punto.
Noam Chomsky scrive che è responsabilità degli intellettuali dire la verità e smascherare le bugie5. Saltiamo a piè pari i discorsi generali su cosa siano verità e bugie, perché sono troppo immensi per stare qui dentro. Questa è un’affermazione che sto prendendo sempre più sul serio. Non per una posizione ideologica, ma perché vedo sempre più spesso, nella mia vita, gli effetti concreti di queste bugie o mezze verità sul controllo, sull’ideologia del self-made man, sul cercare chiarimenti alle proprie esperienze infilandosi in mezze-spiegazioni psicologiche, sulla frustrazione, le cattiverie e i giudizi, che ne derivano.

Non posso agire su interi sistemi, ma posso muovermi entro quello che so. So di essere più sensibile a questi fenomeni rispetto la media delle persone. Sono un po’ come uno “strumento” di precisione che misura “un po’ più” degli altri quello che deve misurare, se mi passate il paragone. Per questo so di dover usare una certa cautela nel farmi coinvolgere in alcune situazioni che potrebbero diventare troppo cariche. Perché non c’è nulla di più fastidioso di un allarme che scatta a ogni soffio di vento, ma non vedo il senso di azzittire tutta questa sensibilità per portarla a livello della norma. Cioè, la questione non è o tutto o niente: posso imparare a capire come muovermi in relazione al mondo che ho intorno. E magari cominciare a chiedere un cambiamento fuori, intervenendo per agevolarlo. Gli esseri viventi non subiscono solo l’ambiente in cui sono immersi, ma lo influenzano a loro volta.
«We argue that imposter feelings are a form of unevenly distributed emotional work, which we call imposter work […]. Students expend time and energy doing emotional work to navigate imposter feelings, with marginalised students experiencing more persistent and intense imposter feelings than their more privileged peers, often in response to, and reinforced by, the exclusionary atmosphere of the university. In short, marginalised students do more imposter work to survive and thrive at university in response to structural inequality.
[…] through which marginalised groups’ imposter feelings tell us something about the exclusionary nature of the institution and provide a position from which to critique the university». Órla Meadhbh Murray, Yuan-Li Tiffany Chiu, Billy Wong e Jo Horsburgh, Deindividualising Imposter Syndrome: Imposter Work among Marginalised STEMM Undergraduates in the UK. Sociology, ottobre 2022.
Riformulare il concetto di sindrome dell’impostore permette di portarlo alla dimensione di sentimento pubblico in relazione a spazi e gruppi specifici, competizione, potere ed emarginazione. Non è una sindrome o una malattia, etichette che si portano dietro il peso di qualcosa di sbagliato, da curare o da eliminare.
«Il normale e il patologico. La medicina ha visto il progressivo sfumarsi della linea che separa i fatti patologici dai fatti normali; o meglio, ha colto con maggiore chiarezza che i quadri clinici non contenevano una collezione di fatti anormali, di “mostri” fisiologici, ma erano in parte costituiti dai meccanismi normali e dalle reazioni adattive di un organismo funzionante secondo la norma […]». Michel Foucault, Malattia mentale e psicologia. Raffaello Cortina Editore, 1997.

Nel momento in cui mi allontano dalla norma dominante, sono una sorta di impostor*, è vero. E a questo aggiungo che la fotografia è una di quelle pratiche che ci mette un po’ a cavallo tra verità e inganno.
«The objectivity of the camera, used wrongly, is the very devil». Minor White.
«Fin da ragazzo avevo capito che la fotografia aveva il dono di imbrogliare nel modo più straordinario, rendendo credibili non solo le cose che erano avvenute, ma quelle che non erano mai esistite. La fotografia riportava in vita l’invisibile, i ricordi che restano nella memoria delle persone e nei luoghi dove è passata la storia. Perché si avverasse questa magia dovevo solo essere preciso, fedele, maniacale nella ricostruzione dei fatti. Io, che avevo un gemello, dovevo costruire un evento che fosse il doppio perfetto di quello che era accaduto nella realtà. Un doppio storico, geneticamente sovrapponibile all’originale. Un doppio vero e falso insieme, perché la fotografia è questo». Paolo Ventura, Autobiografia di un impostore (narrata da Laura Leonelli). Johan&Levi Editore, 2021.
«Quella prima immagine era totalmente, definitivamente ricostituita quando volemmo far uscire l’immagine inattesa, l’immagine sovversiva, la foto.
[…]
Quell’immagine sarebbe qui, davanti a me, probabilmente incorniciata, perfetta e falsa, irreale, ancor più di una foto di gioventù: la prova, il crimine di una pratica quasi diabolica. Nient’altro che un raggiro o un gioco di prestigio: una macchina per fermare il tempo. Perché questo testo è la disperazione dell’immagine, qualcosa di peggio di un’immagine sfocata o velata: un’immagine fantasma...». Hervé Guibert, L’immagine fantasma. Contrasto, 2021.

La fotografia è nata una come una pratica alchemica, con gente che sperimentava e si intossicava nel tentativo di fermare su qualcosa, qualsiasi cosa, questa immagine effimera formata dalla luce.
Alcuni principi teorici fondamentali della fotografia erano noti già nell’antichità, ma non erano mai stati sviluppati nel corso dei secoli perché, possiamo dire, non ce n’era bisogno. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo la scienza, la tecnica e il positivismo hanno trovato nel processo fotografico uno strumento che poteva registrare le cose così com’erano, i fatti, in maniera precisa e oggettiva.
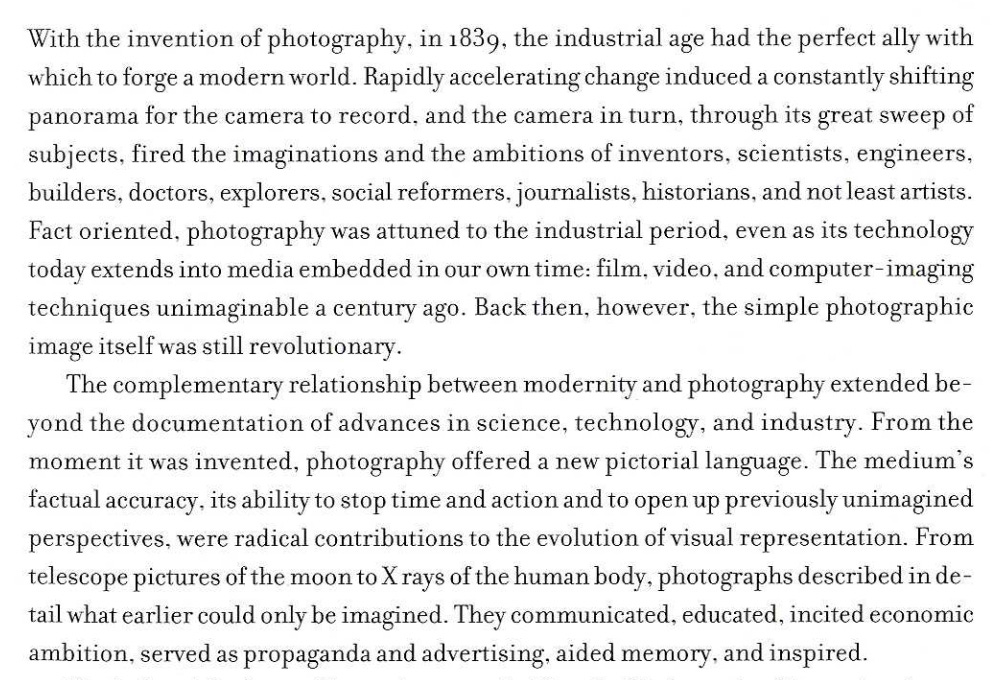
Oppure anche no.

La fotografia non è ambivalente, di più. Può seguire molteplici valori e scopi, utilizzare diversi strumenti. Si porta dietro tutto un carico di dubbi e incertezze che si riversano su chi le immagini le produce. È una sensazione scomoda, vero, a chi piace sentirsi insicur*? Ma non è qualcosa di sbagliato, è il riflesso di questa molteplicità. L’assoluta certezza si trova quando c’è un’opzione unica, o percorrendo strade già battute.
«Quando noi ci mettiamo su qualcosa non cerchiamo altro che di arricchire il rapporto tra noi e ciò che è fuori di noi. Se fate un lavoro, un quadro, una scultura... o siete contenti di come vi è venuto, oppure, se non siete contenti, avete la necessità di arricchire questo tipo di lavoro, di espressione, di rapporto, lo rifate, insistete, lo perfezionate... Per arricchire, il modo giusto non è quello di saltare di palo in frasca. Cerco di farvi capire che il vostro processo è un processo faticoso che vi obbliga a passare attraverso l'autodisciplina. Dovete lavorare, ostinarvi, dovete disciplinarvi...
[…]
Disciplina vuol dire anche forza nel difendere il proprio miglioramento da tutte le interferenze...Chi si ostina deve rinforzarsi perché siamo tutti costantemente circondati da pressioni, da violenze che vogliono farci fare altro.
C’è anche un’altra questione: tutto vi viene dato già confezionato. Voi siete ridotti a un punto in cui non potete guardare un quadro di Picasso senza vedere già tutti i problemi che sono stati letti in Picasso....Anche se guardate superficialmente Picasso e la sua lettura vi vengono passati insieme, preconfezionati. Come i concetti, anche i materiali che usate sono preconfezionati […]. Per portarli nel nostro spazio i materiali del pensiero devono agire su materiali preconfezionati. Per modificarne l’uso dobbiamo sapere il come, il perché, il per cosa, il quando... se non si sa esattamente come usarli, si fa una cosa che non ha senso fare. Dunque dovete trovare senso in qualsiasi cosa facciate, qualsiasi cosa adoperiate, ma un senso che dovete approfondire attraverso i vari processi di pensiero, di esperienza, di stadio e di prova...». Luciano Fabro, (a cura di Silvia Fabro), Lezioni 1983-1995. Libri Scheiwiller, 2022.
C’è un problema nel modo in cui si parla della sindrome dell’impostore tra fotograf* e creativ*. Non nei contenuti delle esperienze di ciascuno, quelli sono sacrosanti, ma in questi tentativi di risolvere i sintomi controllando e imponendo atteggiamenti, modificando o riducendo il nostro modo di sentire. Il che per me è assurdo. Mi auguro di coltivare la mia sensibilità, non di normalizzarla. Non creiamo e fotografiamo per diventare macchine di produzione, ma per alimentare la capacità di scoprire narrative non dominanti, di associare e rielaborare concetti, di costruire con i gesti e la materia. E poi ancora per coltivare la relazione, la capacità di raccontare e raccontarsi agli altri.
La nostra eredità culturale ci insegna che l* creativ* è divers*. All’incirca con l’epoca moderna è nata questa figura di artista come individuo straordinario, mitico, visionario. Per chi diverge i fenomeni della vita “normale”, anche solo in un certo ambito, non sono trasparenti. Questo permette di mettere le cose in discussione, di trovare soluzioni originali.
Quello che spesso passa inosservato è che, all’interno di un gruppo qualsiasi, ricoprire la posizione di divers* equivale a fare i conti con l’insicurezza, la sensazione di non avere punti di riferimento, il dubbio. Magari non sempre, ma spesso. È la sensazione della minoranza. E queste insicurezze non vivono nel vuoto cosmico del nostro sentire, ma in relazione ai periodi storici e culturali, che possono a loro volta contenerle o amplificarle.
«Every age, every culture, every custom and tradition has its own character, its own weakness and its own strength, it beauties and ugliness; accepts certain sufferings as matters of course, puts up patiently with certain evils. Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap... Now there are times when a whole generation is caught in this way between two ages, two modes of life, with the consequence that it loses all power to understand itself and has no standard, no security, no simple acquiescence. Naturally, every one does not feel this equally strongly». Herman Hesse, Steppenwolf. Penguin Modern Classics (Edizione Kindle), 2012.
Riassumendo: dovremmo spingere questa vena creativa e soffrirne le conseguenze come se fossero una sindrome di sola e nostra assoluta resposabilità? E qual è il prossimo passo? Vendere l’anima?
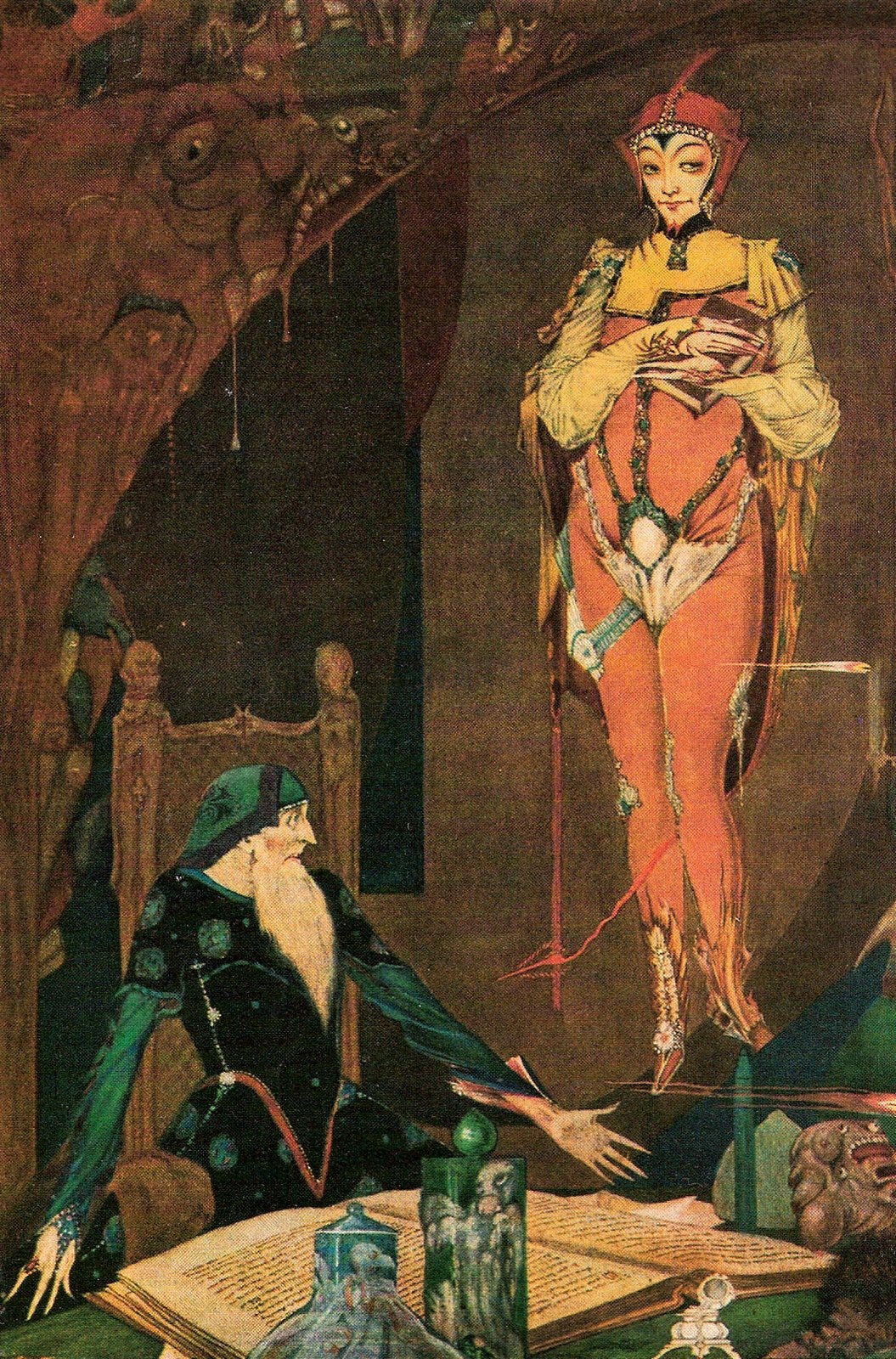
Farsi carico del ruolo di impostor*, accettando la definizione di sindrome come qualcosa di solo nostro rischia di mettere chi fotografa e lavora con le immagini in una posizione di svantaggio. Forse ancor più di quanto non sia già, direi, visto che si tratta di settori in grado di creare un enorme valore ma dove le risorse economiche e di potere spesso scarseggiano. L’effetto ultimo, e più grave, è quello che porta a gettare la spugna. A rinunciare a costruire la propria identità narrativa, a perdere volontà e capacità di raccontarsi agli altri attraverso la relazione. A chiudersi in sé stess*, in un conforto autoreferenziale, come in un bozzolo. Che è sempre una sensazione piacevole (e di tanto in tanto, perché no?), ma lasciamo che il dubbio ci impedisca di fotografare? Rinunciando così a uno strumento di scoperta e affermazione, a un pezzetto di cuore e a un po’ della nostra libertà?
«I believe that using a camera can draw us away from our selves. That it is a meaningfully constrained way of thinking and knowing that enables us to conjure relationships among otherwise uncooperative earthly things; new and valuable correspondences which never actually existed. That these novel sets of relationships - called “photographs”- are useful because of the independent authority they possess to both defy and embrace impermanence and to convey to other human beings the essence of a separate self’s fleeting and often furtive connections with the obstinate thusness of it all. In short, that such pictures can get us about as close to the ineffable as our mortal shortcomings will allow.
And what’s more: working with the camera has the warrant to turn this whole fearful mess on its head: to demonstrate that humility in the face of the actual and the transient has the paradoxical power to effect a true and earned freedom». Tim Carpenter, To Photograph Is to Learn How to Die: An Essay with Digressions. The Ice Plant, 2023.
Ci ho trovato un manuale operativo della WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) che, detta in due soldoni, è un test per misurare l’intelligenza negli adulti. Si potrebbe fare un discorso sulla storia, lo sviluppo e gli usi e abusi dei test cognitivi e di personalità (ci potrebbero fare una serie, e sarebbe interessantissimo e utile, davvero) ma riassumo scrivendo che i test sono strumenti. Esattamente come un bisturi o il trapano del dentista, richiedono una formazione apposita e continui aggiornamenti (oltre alla laurea e all’abilitazione in campo psicologico o psichiatrico) e, almeno in Italia, i manuali dei test dovrebbero essere venduti solo da una casa editrice specializzata a professionisti verificati. Il fatto è che molto spesso questi strumenti sono utilizzati male, anche da “professionisti” che non hanno la formazione per somministrarli e interpretare i risultati, e questo diventa un problema quando il test serve a formulare una diagnosi, o viene usato per prendere decisioni che influiscono sulla vita e sulla salute delle persone. ↩
Órla Meadhbh Murray, Yuan-Li Tiffany Chiu, Billy Wong e Jo Horsburgh, Deindividualising Imposter Syndrome: Imposter Work among Marginalised STEMM Undergraduates in the UK. Sociology, ottobre 2022. ↩
STEMM: acronimo che riassume le discipline tecnico-scientifiche (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine). ↩
Órla Meadhbh Murray, Yuan-Li Tiffany Chiu, Billy Wong e Jo Horsburgh, Deindividualising Imposter Syndrome: Imposter Work among Marginalised STEMM Undergraduates in the UK. Sociology, ottobre 2022. ↩
«It is the responsibility of intellectuals to speak the truth and expose lies». Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals: Fiftieth Anniversary Edition. The New Press Edizione Kindle 2017 ↩
No spam, no sharing to third party. Only you and me.






