#3.5 La pratica senza un corpo

Ci sono periodi in cui Instagram mi mostra in serie solo video di gente che mi racconta quanti soldi ha fatto, mese per mese, con la sua attività creativa. Forse è un modo dell’algoritmo per dirmi “dai, forza, ce la puoi fare anche tu. Guadagna qualche soldo, così poi sponsorizzi finalmente qualche post”.
Vabbé, comunque.
Sono tanto contenta per loro, anche se a me hanno sempre insegnato che non è educato parlare nello specifico di quanti soldi si guadagnano o si spendono. Danno quel falso metro di misura sul valore della vita di una persona per cui se vengo a sapere che guadagni n-mila euro al mese, allora di sicuro te la passi bene e sei felice. Ma magari invece sei spiantato lo stesso perché ne spendi n-mila-uno per mantenere te, contribuire alla famiglia, pagare la badante per la bisnonna e coprire i debiti che il prozio Ugo ha contratto nel 1963. E tutto questo senza che nessuno, in tutta la tua vita, ti abbia dato qualche nozione base di gestione economica. Una bella pacca sulla spalla, imparerai strada facendo. L’unica certezza: i soldi si fa prima a spenderli che a farli.
Gestisco da qualche anno ormai un’attività per cui, ad un certo punto e dopo un po’ di errori che avrei voluto evitare, ho imparato a trattare i soldi per quello che sono: un modo per poter continuare a fare quello che faccio, giorno dopo giorno. Qualche volta vorrei svegliarmi la mattina e vivere in una dimensione alla Star Trek, dove non esiste il denaro e la gente lavora semplicemente per il bene comune e per la realizzazione personale1.

E invece sono nata in una realtà che assomiglia di più al tabellone del Monopoli, con regole che cambiano in base alla pedina che ti capita. In più, a un certo punto, ho deciso io di buttarmi in quest’avventura da lavoratrice autonoma, in Italia, in un periodo di crisi economica, per cui se questo è il gioco, giochiamo.
Ancora oggi è difficile mettere insieme in un discorso soldi e lavori creativi. Di solito si taglia corto: non ce ne sono. Che un po’ è vero, ma è anche un modo per tenere il denaro e creatività su piani diversi. Il lavoro è quella cosa che fai in cambio di soldi, e se i soldi nell’arte non esistono, allora fare arte non è un lavoro2. Non si possono fare budget, preventivi, piani o fogli excel con l’aria. Non si può nemmeno cercare di far quadrare i conti con quel poco che c’è.
«Art is work. The fact that people do it out of love, or self-expression, or political commitment, doesn’t make it any less so». William Deresiewicz, We Need to Treat Artists as Workers, Not Decorations. William Deresiewicz on the Dangerous Illusion of Art As a Labor of Love. Literary Hub, 5 agosto 2020.
Ora, “la fotografia” è un campo enorme e ci sono mille ragioni che influiscono sul suo valore di mercato. Diventare bravi in quello che si fa, costruire un buon prodotto o servizio sono solo due ingranaggi di un meccanismo molto più complesso.
Ma più che parlare di soldi, contratti e mercato3 vorrei fare un passo “dietro le quinte” per esplorare proprio questa percezione della creatività come un non-lavoro. Un’attività ricreativa che non produce un valore “vero” (che sia economico, strumentale, informativo, emotivo e via dicendo). O anche un processo che, invece di essere accettato per quello che è, dovrebbe generare una qualche forma di guadagno.
È un atteggiamento culturalmente e storicamente definito che spesso interiorizziamo. In sostanza vuol dire che siamo condizionati a giudicare le pratiche creative come un passatempo, per cui alla fine le mettiamo sul fondo della lista delle nostre priorità. Forse, a volte, facciamo meno fatica a mettere in calendario un’ora per andare a farci strappare i peli che per dedicarci alla nostra fotografia. La cura della persona è importante. Ma anche fare qualcosa che sentiamo, prenderci del tempo per noi, conta come cura. Davvero. Influisce sulla percezione di controllo sul tempo e sulla propria vita, alimenta il senso di autoefficacia che è grosso moderatore psicologico in grado di attenuare bilanciare le piccole e grandi sfighe quotidiane4. Detta in altre parole, il senso di autoefficacia ci rende più forti.
Impariamo, poi, a vedere l’arte come un qualcosa che riguarda queste figure mitologiche dell* artista-genio, o influencer sul social di turno che non si capisce bene come faccia a portare avanti la sua vita.
L’arte è mente e spirito, può muoversi al di fuori delle regole della fisica, dello spazio e del tempo, vive nella dimensione delle infinite possibilità.
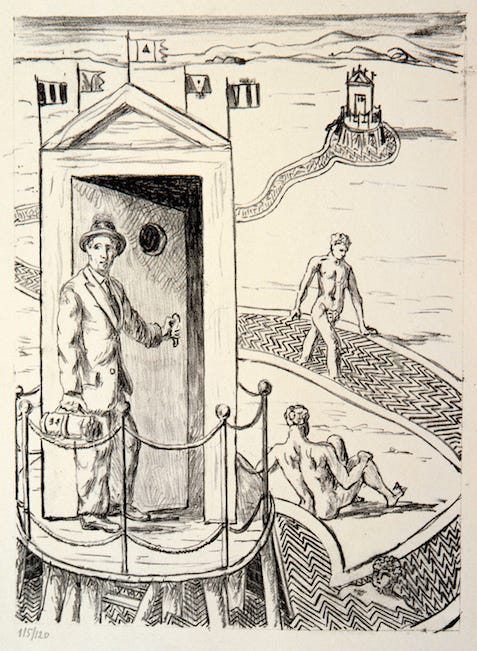
Ma l’arte è anche corpo e materia, ha limiti e bisogni che vanno sostenuti. Processi che richiedono tempo, prove ed errori. Questa è la parte del lavoro “fisico” della creatività che fatichiamo a vedere, quella dove ci mettiamo il corpo, sporcandoci le mani.
Volevo parlare dell’educazione artistica nel sistema scolastico, ma in realtà ne so davvero poco. Ecco la mia esperienza. Tra elementari e medie arte erano due ore di ricreazione in più una volta a settimana in cui si facevano cose che al limite venivano regalate a Natale o messe all’asta per beneficenza. Forse otto anni così bastano per insinuare l’idea che i prodotti dell’arte siano solo suppellettili?
Alle medie ho imparato i concetti di talento e competizione. C’era chi era brav*, mentre per tutti gli altri non aveva gran senso impegnarsi. Anche se i voti alti in educazione artistica non contavano poi molto in pagella, c’era un po’ la ricompensa sociale dell’essere vist* come artista. Equivalente più o meno a quella di chi andava bene in ginnastica, aveva un discreto valore ai miei tempi. In pratica servivano a dimostrare che non eri secchion*.
Al liceo, poi, cinque supplenti diversi per la cattedra di storia dell’arte. Chi faceva l’artistico ci andava perché non aveva voglia di studiare. Fine della mia esperienza con l’arte a scuola.
Da un lato penso sarebbe bello avere un percorso più ampio e articolato già nella scuola. Dall’altro temo verrebbe inglobato nella struttura delle materie al servizio di un sistema economico, senza la possibilità di scoprire e ricavarsi percorsi alternativi.
Quindi, parlando sempre in generale, usciamo da scuola già con le idee confuse su cosa sia l’arte ai giorni nostri. Chi pratica la creatività a volte diverge dai ruoli “normali” della società, e questo può portare qualcun* a caricarl* di una sorta di alone di attivismo politico per cui tu disegni, balli, suoni o fotografi per scardinare in qualche modo un sistema. O chissà cos’altro. Ad ogni modo sembra chiaro che qui, nel mondo reale, la vita non ti sarà facile. A meno di non eccellere. Quanto talento hai da spendere?
È tutto un discorso fatto di polvere e illusioni. O è tutto magnifico oppure è il nulla. Ci si concentra davvero poco sulle possibilità reali, a sfruttare i punti di forza e a identificare e arginare le aree problema. Ma gli estremi appartengono solo alle utopie.
«It’s important to create the illusion that it’s not a business and that your relationships do not exist to serve your career». Paper Monument, I Like Your Work: Art and Etiquette. Edizione Kindle.
Qualche volta sembra persino che arte e lavoro si escludano a vicenda. La prima si svolge su di un piano mistico, astratto, il secondo su quello pratico e della fatica. Il complimento più probabile per un* fotograf* è che sia un talento naturale, piuttosto che un gran lavoratore. Una figura misteriosa, veicolo di chissà quale illuminazione, contro chi si presenta tutti i giorni ad arare il proprio campo.
L’arte è anche corpo, non solo “genio”. Come tutti gli esseri viventi anche chi fotografa ha bisogno di mangiare, dormire e percepire una certa stabilità nella propria vita per poter lavorare.
In psicologia ci sono una manciata di modelli che descrivono i bisogni degli individui.

Maslow mette alla le necessità fisiologiche e man mano sale verso bisogni sempre più astratti, o psicologici, come la creatività. Di base c’è l’idea che non sia possibile occuparsi dei bisogni dei piani più alti se quelli sottostanti non sono soddisfatti. Questo modello pecca sotto molti aspetti: la piramide è troppo rigida, non considera le forze sociali, i bisogni vengono considerati uno alla volta. Ma per un discorso generale si può prendere ancora per buono5. Nella mia esperienza tutta la passione fotografica passa in secondo piano quando l’ansia di non riuscire a pagare tutti i conti bussa alla porta.
«“Dubito di poterla aiutare in qualche modo, signore, sono un povero diavolo. Ma mi dica.”
“Ho bisogno di recuperare la mia dignità, i miei denti nella fattispecie […]. E a te servono soldi, tempo, libertà, pace, esperienza lavorativa, vita di strada, donne, stimoli, e tutto ciò che sicuramente richiedono i tuoi capolavori.”
“È così, signore.”
“Ma non ci riesci. Non hai nulla di tutto ciò perché impieghi due ore al giorno per raggiungere quello schifoso centro della città, dove lavori per un figlio di cagna che ti sfrutta, e ritorni nel tuo appartamento, dove vivono altri giovani come te, vestiti nello stesso modo strano, e la casa è un porcile, e quindi ti metti in cucina a lavare i piatti, a spazzare palle di pelo per terra, a piegare magliette, stendere calzini spaiati, e poi ti fai un panino di solo formaggio perché il prosciutto è già diventato un po’ verde moccolo, e alla fine della giornata sei talmente stanco e depresso che hai perso la voglia di sederti a fare l’unica cosa che ti piace fare, ovvero scrivere.
«Sono senza parole, signor Autostrada. Come fa a sapere delle palle di pelo?». Valeria Luiselli, La storia dei miei denti. La nuova frontiera, 2018.
L’arte che nasce solo dalla sofferenza di chi la crea è un mito. Il prodotto del dolore, della privazione fisica e/o spirituale di un individuo per me è sfruttamento. Il rischio di considerare la fotografia o qualsiasi altra pratica artistica prevalentemente nella sua dimensione intellettuale e astratta sta nel dimenticarsi della sua componente fisica, del gesto, della materia e dei suoi limiti. Il pericolo di scordarsi che la pratica si svolge nel tempo e nello spazio.
«Comprese che l’impegno di modellare la materia incoerente e vertiginosa di cui sono composti i sogni è il più arduo che un uomo possa intraprendere, anche se riuscisse a penetrare tutti gli enigmi dell’ordine superiore e di quello inferiore; molto più arduo che tessere una corda di sabbia o coniare in monete il vento senza faccia. Comprese che un fallimento iniziale era inevitabile. Giurò di dimenticare l’enorme allucinazione che lo aveva sviato all’inizio e cercò un altro metodo di lavoro. Prima di praticarlo, dedicò un mese a recuperare le forze che il delirio aveva logorato. Abbandonò ogni premeditazione di sognare e quasi immediatamente riuscì a dormire una parte ragionevole del giorno. Le rare volte che sognò in quel periodo, non fece caso ai sogni». Jorge Luis Borges, Le rovine circolari in Finzioni. Gli Adelphi, 2003.
A volte nella nostra testa ci dimentichiamo di avere dei limiti, pensiamo di essere infiniti. Un po’ come bimb*, che a una certa età dicono ho corso velocissimo, 100 chilometri all’ora, perché la mente non ha ancora ben afferrato i riferimenti fisici del mondo. Tutto è possibile nell’immaginazione, ma i talenti si esprimono qui e ora.
«Poi riflettei che tutte le cose capitano a ciascuno esattamente, esattamente adesso. Secoli di secoli e solo nel presente succedono i fatti». Jorge Luis Borges, Il giardino dai sentieri che si biforcano in Finzioni. Gli Adelphi, 2003.
E qui, ora, oggi, in quest’epoca, tra le cose che contano di più ci sono i soldi. Capirlo non vuol dire farli diventare automaticamente il fine ultimo della fotografia, ma un mezzo per alimentarla. Le attrezzature hanno un prezzo, così come i corsi, le mostre e tutto quello che può servire per crescere e imparare. I soldi a volte comprano anche il tempo, per potersi prendere mezza giornata tanto per noi, per dire. It’s a long way to the top if you wanna rock and roll.
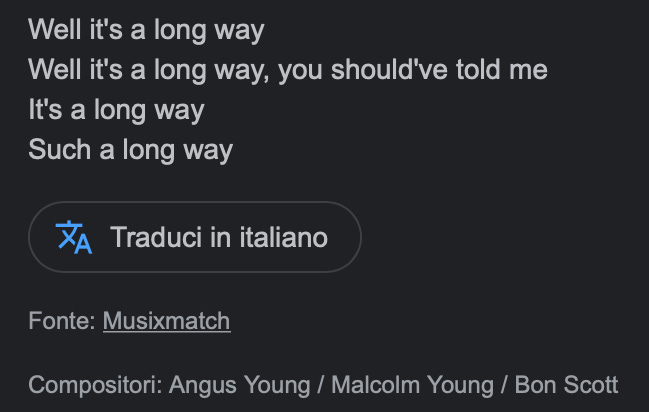
Le pratiche artistiche danno agli individui la possibilità di conoscere gente al di fuori dei propri legami famigliari, lavorativi o territoriali. Permettono di allargare e arricchire le proprie reti sociali. Di entrare a far parte di comunità diverse, di investire nel proprio capitale sociale (in senso psicologico, non economico). Posso anche essere un topo di camera oscura che non esce mai di casa ma riuscire lo stesso a trovare una lontra simile a me in Uzbekistan e creare una relazione, basata anche solo su formule chimiche se è questo che mi fa stare bene. Non è bello?
Che sia per lavoro, passatempo o crescita personale molte persone non riescono o non possono sostenere una pratica creativa da sole, senza un sostegno (economico, logistico o emotivo). E non solo per mancanza di motivazione e organizzazione, ci si mette anche la pressione della società. Sommiamoci poi il mito individualista, dell’eroe solitario, che ha pieno controllo della sua vita ed è l’unico responsabile dei suoi successi e delle sue disgrazie ed ecco che otteniamo una bella strada in salita verso la pratica della fotografia.
La nostra cultura valorizza l’indipendenza, chi ce la fa da solo, soprattutto negli ambiti che possono alimentare accese competizioni (il lavoro, lo sport) e successi idealizzati (l’arte).
I miti diventano riferimenti di comportamento, personaggi a cui aspirare e magari copiare. Quando entriamo in contatto per la prima volta con una comunità fotografica (reale o virtuale) impariamo un certo numero di figure di riferimento. A dire il vero le cerchiamo anche, per capire bene cosa vuol dire essere fotograf*.
Uno dei primissimi miti ai quali sono stata esposta è stato Ansel Adam. Parliamo di quasi vent’anni fa, lavoravo come programmatrice in una grossa azienda che si occupava, tra le altre cose, di digitalizzazione di opere d’arte e documenti antichi. Io passavo tutto il giorno al computer a programmare software archivistici, associare parole chiave e immagini. Tutta roba che oggi forse l’AI potrebbe fare tranquillamente da sola. Vabbé, torniamo al discorso.
Il mio ufficio era appena prima del reparto fotografico perciò vedevo ogni giorno un andirivieni di attrezzature, banchi e macchine fotografiche da studio, insieme al personale che lavorava lì. Io avevo da poco cominciato a fotografare con una reflex digitale, perciò cercavo di carpire qualche consiglio da chi ci lavorava tutti i giorni. Uno di questi, probabilmente per prendermi in giro, o magari ci credeva davvero, non lo sapremo mai, mi disse che dovevo assolutamente studiare Ansel Adams e il sistema zonale. Sta di fatto che io volevo davvero imparare bene la fotografia, perciò qualche giorno dopo andai in una libreria sotto i portici di Torino e me ne tornai a casa trascinando i tre tomi “La Fotocamera”, “Il Negativo” e “La Stampa” con le loro custodie in cartone. Me li sono studiati tutti. L’ultima volta che avevo fotografato in pellicola era con la Kodak usa e getta blu, quella subacquea, al mare. Ma non importava. Per un sacco di tempo io volevo diventare una Ansel Adams, ed ero convinta che la mia strada fosse la fotografia paesaggistica. Beata gioventù6
Nella storia della fotografia si sa tutto di quello che si deve sapere dell’Ansel Adams e si ignora tutto il resto. Quando guardiamo una persona tendiamo a concentrarci molto su di essa e molto poco su tutto quello che succede nell’ambiente circostante, alcuni psicologi lo chiamato effetto osservatore-attore7. Quello che spesso chi osanna Ansel Adams ignora è Virginia Best.
«After their marriage, Ansel’s career—which had shifted to photography—began to take off». Virginia Best Adams: The Woman Behind The Legend, The Ansel Adams Gallery.

Quello che non riusciamo a vedere quando attribuiamo tutto il merito del successo solo all’individuo è il suo capitale sociale (oltre al contributo delle circostanze). Ovvero tutta la rete di contatti che offrono supporto strumentale, informativo e anche emotivo.
Per molti decenni anche la psicologia si è occupata quasi esclusivamente dello studio dei grandi personaggi singoli, dei tratti del genio, delle teorie del grande uomo nella leadership. Solo negli ultimi decenni si è cominciato a guardare al valore delle relazioni, delle comunità e dei piccoli gruppi.
Il mito del self-made man va a braccetto con quello dell’indipendenza economica e della produttività per cui, ad un certo punto, quello che fai deve procurarti un certo tipo di guadagno economico o sociale (come successo e fama). È una roba che cela un certo senso di competizione e mi viene il dubbio che, in fotografia, siano i resti di un’impronta maschilista-tossica. Ma questa è solo una mia considerazione. Una cosa del tipo “i veri uomini hanno UN lavoro vero e portano a casa lo stipendio”. Mah.
Per quel che vale, io non mi mantengo mica facendo solo servizi fotografici. Anzi. Negli ultimi anni ho postprodotto immagini di altri, ho venduto foto di archivio, ho fatto consulenze/lezioni. E poi, al di fuori della fotografia: lavoro con mio marito a strategie di marketing, facciamo consulenza informatica e poi tutta un’altra serie di attività che coinvolgono fogli excel, programmazione e calcoli. Ci sono mesi in cui la fotografia va bene, e non nascondo la soddisfazione quando succede. Ma non basta.
Le cose per me stanno così: in questo momento il mondo è un luogo troppo ostile per incaponirsi solo su quello che ci piace fare e nel volercela fare a tutti i costi da sol*. Non dico sia impossibile vivere bene di sola fotografia. Diciamo che in questo momento mi vengono in mente più esempi di fotograf* con carriere miste che uniche e prosperose.
E, tra parentesi, il modello classico di carriera verticale sta andando in crisi anche negli ambiti aziendali, non solo tra i lavoratori autonomi.
«As employees become more self-motivated and seek greater career flexibility, the “career lattice” is rapidly replacing the traditional career ladder as a means of connecting them to a wider range of opportunities within the organization.
The career lattice is a new approach to career progression that promotes movement in multiple directions - lateral, diagonal and down, as well as vertical. This approach promotes greater flexibility and choice, replacing traditional vertical career ladders with a more diverse range of multi-directional moves. Because this type of latticed movement allows employees to explore career paths that extend across different disciplines, departments, or business units, the resulting approach is often called “career pathing”». Career Lattices: A New Approach to an Old Challenge, HRGS, 2022.
Sarebbe bello poter dedicare tutto il tempo alla fotografia, e ai miei progetti, ma questo è un mondo ideale. E vivere con la testa in questo sogno mi impedisce di vedere le piccole opportunità, le nicchie favorevoli in cui operare, per poter piantare le radici qui, ora, adesso, nella realtà presente e non nel mondo dei se.
Noi non possiamo sapere se chi abbiamo di fronte, fotograf*, artista o influencer di turno conta effettivamente solo sulle proprie forze o ha altri ingressi, si mantiene con un lavoro da dipendente o c’è chi paga le sue bollette. Ma è davvero così importante?
Può diventare un problema quando l’illusione di indipendenza viene passata ai neofiti della pratica come una regola, un obiettivo da raggiungere, perché crea aspettative esagerate e impossibili. Ma costruire un “ecosistema” per supportare la mia pratica, una rete di aiuti e ingressi laterali che funziona e rispetta me e le persone che mi stanno intorno, nulla toglie a quello che faccio. Cioè, toglie solo quel pezzo di valore sociale che è legato al mito individualista, che forse è il caso di ridimensionare un po’.
La magica arte di trovare compromessi, di negoziare con i limiti che ci impone la realtà per avvicinarci a quello che vogliamo. Se questa non è una forma di creatività, poche altre cose lo sono.
«Da un lato siamo costretti ad abbassare l’asticella delle nostre pretese all’unicità e all’indipendenza. Quella stupenda autoillusione di essere i migliori ed unici esseri liberi sulla terra, e come singoli e come specie umana, ce la possiamo dimenticare per sempre. Dall’altro però questa visione si apre la prospettiva etica della resistenza, dell’esame critico del reale e della presa di posizione pubblica […]». Giacomo Marossi, Il mito dell’origine: studiare il potere tra natura e libertà – seconda parte. Padora Rivista, 2015.
Dare da mangiare a questo corpo affamato, riuscire in qualsiasi modo a trovare una base sicura, ci permette anche di acquisire quel pochino di potere che può permetterci qualche volta di dire no alle offerte scandalose, di non lasciarci sopraffare.
L’idea che nell’essere umano l’intelletto vinca sopra la fisicità è un concetto che ha radici molto profonde.
«[…] è abbondantemente sviluppato da Aristotele, che in PA 686a 25 sottolinea in merito l’importanza dell’organizzazione del corpo umano: l’uomo infatti partecipa del “divino” grazie alla stazione eretta e all’equilibrata proporzione del corpo secondo l’asse alto/basso, mentre negli altri animali la regione superiore ha dimensioni eccessive e “grava” sull’anima». Andrea Libero Carbone, Aristotele - Problema XXX. Saggezza, intelletto, sapienza. Editore :duepunti, 2011.
«Perché tutti gli uomini straordinari sono melancolici? Con questa domanda si apre il Problema XXX attribuito ad Aristotele, […] “una monografia sulla bile nera”. Oggetto del Problema è infatti la melancolia come affezione patologica e disposizione caratteriale suscettibile di provocare prestazioni fuori dal comune in vari ambiti del sapere e dell’agire umano.
[…] la tesi dell’identità di melancolia e genio viene qui per la prima volta formulata in maniera originale e giustificata su base fisiologica. Il Problema XXX ha dunque rappresentato il più importante riferimento di una lunga tradizione che dall’antichità a oggi si è interrogata sul rapporto tra la follia e l’estro, la malattia e il genio, la depressione malinconica e l’ingegno creativo […]». Aristotele, Problema XXX, 1: perché tutti gli uomini straordinari sono melancolici. Edizioni ETS, 2018.
E da qui poi discendono profili e caratteristiche di uomini straordinari che, nei secoli, sono state associate sempre di più a poeti, artisti e individui dal sentire eccezionale. Idee che si trasformano ma che rimangono come frequenze di fondo, un riverbero impercettibile che ogni tanto ritorna in qualche forma. O forse solo come una coincidenza nella quale, alla fine, l*artista non ha corpo.


«The birth of this new humanist awareness took place, therefore, in an atmosphere of intellectual contradiction. As he took up his position, the self-sufficient “homo literatus” saw himself torn between the extremes of self-affirmation, sometimes rising to hubris, and self-doubt, sometimes sinking to despair; and the experience of this dualism roused him to discover the new intellectual pattern, which was a reflection of this tragic and heroic disunity -the intellectual pattern of “modern genius”. At this point we can see how the self-recognition of modern genius could only take place under the sign of Saturn and melancholy; and how, on the other hand, a new intellectual distinction now had to be conferred on the accepted notions of Saturn and melancholy». Raymond Klibansky, Erwin Panofsky and Fritz Saxl, Saturn and Melancholy. Studies in the
History of Natural Philosophy, Religion and Art. Thomas Nelson & Sons, 1979.
In questo post uso arte, creatività e fotografia come termini generali, per indicare tutte le figure, professionali e non, che includono. Restano le rispettive differenze, ma sarebbe stato tropo lungo parlarne. ↩
A questo proposito lascio i riferimenti di TAU Visual e Art Workers Italia, per chi non li conoscesse. ↩
Se volete approfondire il discorso potete cercare le teorie di Murray e McClelland. ↩
Ma quel periodo non è stato tempo sprecato, fa parte del processo che mi ha resa la fotografa che sono oggi. In più buona parte del materiale che ho prodotto 10-15 anni fa lavora ancora per me attraverso le piattaforme di stock. Non si butta via niente. ↩
In pratica tendiamo a spiegare di più il comportamento degli altri attribuendolo cause interne o tratti di personalità che alle circostanze. ↩
No spam, no sharing to third party. Only you and me.






