#4.6 Un leggero languorino

Ricordate la pubblicità di inizio anni ‘90 del Ferrero Rocher? Quella con la madama in giallo che avverte un leggero languorino, ma che non è proprio fame, è più una voglia di...qualcosa di buono.
Di buono o di nuovo?
Le prime tre volte che ho riguardato il video, giuro di aver sentito nuovo. E non so quanto sia dovuto al caso, oppure al genio di chi ha ideato lo spot. Perché se è vero che la voce dice buono, tutto nelle immagini e nel contesto suggeriscono nuovo. L’auto nel traffico, la madama con il cipiglio e il tono di voce di chi ha già tutto nella vita (o può ottenerlo facilmente), e Ambrogio, trovami una soluzione. Manca proprio una scintilla, qualcosa di eccitante, per svoltare la giornata. E voilà, come per magia, appare una piramide d’oro di Ferrero Rocher, e tutto è bene quel che finisce bene.
Se non è una dimostrazione di genio della comunicazione, questa, non saprei cosa altro dirvi. Cioè, capiamoci, il Ferrero Rocher: buono, per la gran carità, ma è una pralina di cioccolato e nocciola. E miseria, saranno mille anni che è sempre uguale: stessa ricetta, stessa carta, stesso tutto. Alla faccia della novità. Ma i pubblicitari del Signor Ferrero questo lo sanno, e mica possono dirti apertamente che è nuovo, perché poi, se la gente si sente scema, non compra più. E allora te lo fanno desiderare “come se” fosse eccezionale.
Perché sappiamo tutti benissimo che il Rocher è sempre la stessa roba, ma il desiderio di qualcosa di nuovo, di diverso, che stravolga le cose che ci vengono a noia, quello ce lo portiamo dietro sempre.
Io non ho un Ambrogio, ma ogni tanto provo a chiedere ai vari algoritmi di Spotify, Instagram e Netflix di suggerirmi qualche scintilla. Spesso falliscono (sono difficile, lo ammetto), ma a volte ci riescono e mi fanno contenta per un po’.

Per quanto riguarda la fotografia, invece, le cose si fanno un po’ più complicate. Cerco di tenermi aggiornata su più fronti sui temi che mi interessano che, per riassumere, ruotano tutto intorno alla salute mentale. Ci sono tante conversazioni interessanti in corso, molte delle quali portano a galla la necessità di lavorare per creare delle rappresentazioni nuove. Si, ma quali?
Qui non si tratta solo di un languorino, ma di una fame vera e propria di fotografie diverse, che cambino le cose, che è un desiderio che forse sopravvaluta la forza delle immagini, ma che per me è legittimo. Perché, come fotografa, voglio poter esplorare, e conoscere, e parlare della realtà che mi interessa e considero importante. E credo anche che la fotografia sia un ottimo modo per farlo ma, forse, non nel modo in cui l’ho approcciata finora.
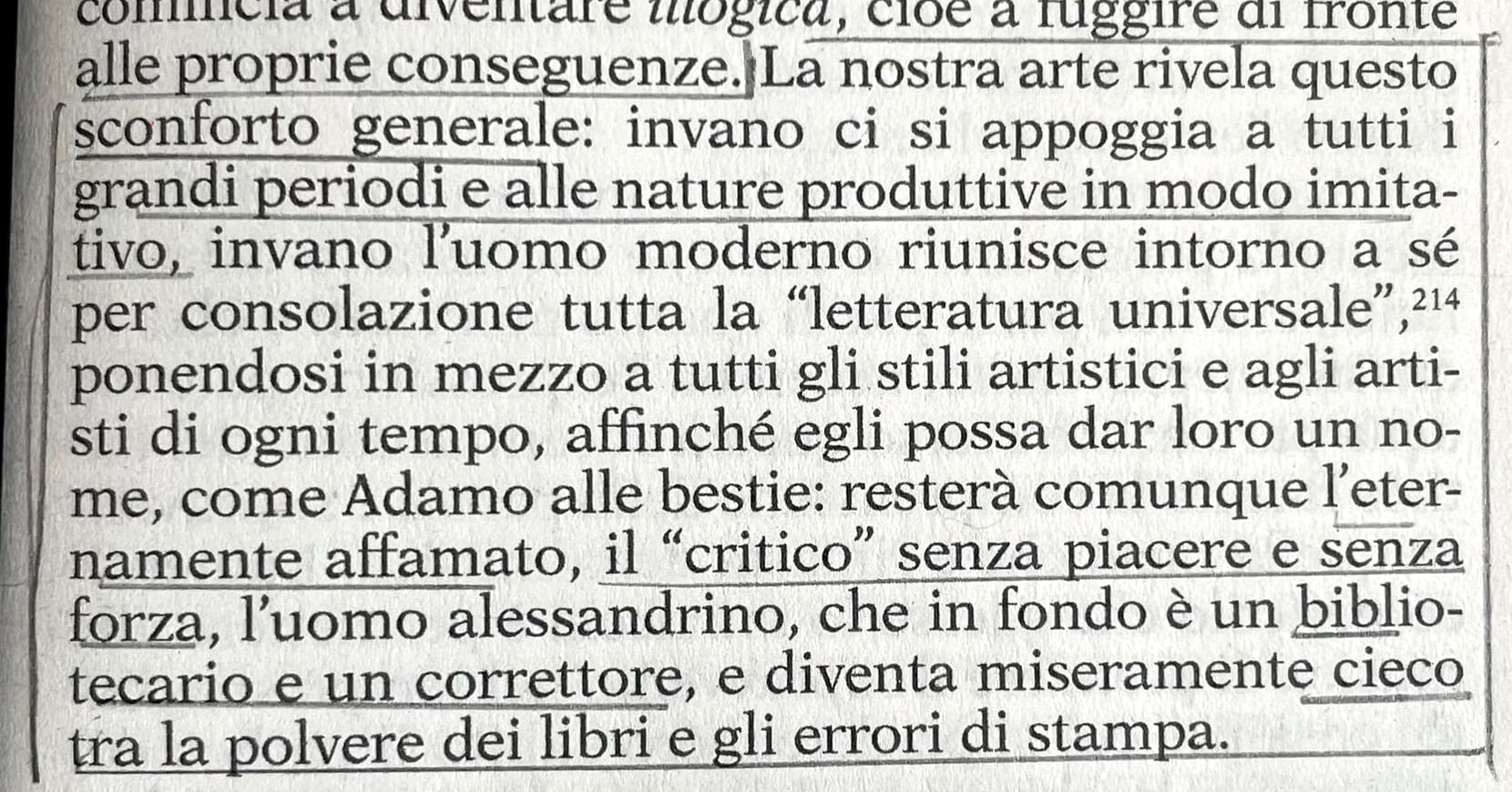
Ho spesso sostenuto di utilizzare la fotografia come mezzo per esplorare la realtà o, perlomeno, le parti che mi interessavano. La macchina fotografica è quindi uno strumento per creare e diffondere conoscenza (o senso). Per generare, oltre che esplorare, narrative e rappresentazioni sempre nuove. Questo lo scrivo qui ora in poche parole, condensando un discorso molto più complesso per aiutarmi a tenere il filo dei pensieri. Possiamo dire, sacrificando la precisione per semplificarci le cose, che questo è un approccio cognitivista: lavoro con rappresentazioni e schemi che interagiscono con il modo in cui percepiamo e parliamo del mondo.
E va benissimo. È un approccio. Lo specifico perché, sollevando tante questioni non vorrei che passasse il messaggio di un confronto tra metodi. Non mi interessa fare questo esercizio, arrivando a dimostrare la superiorità dell’una o dell’altra cosa: parlo al di là delle categorie di giusto/sbagliato, per sostenere una riflessione.
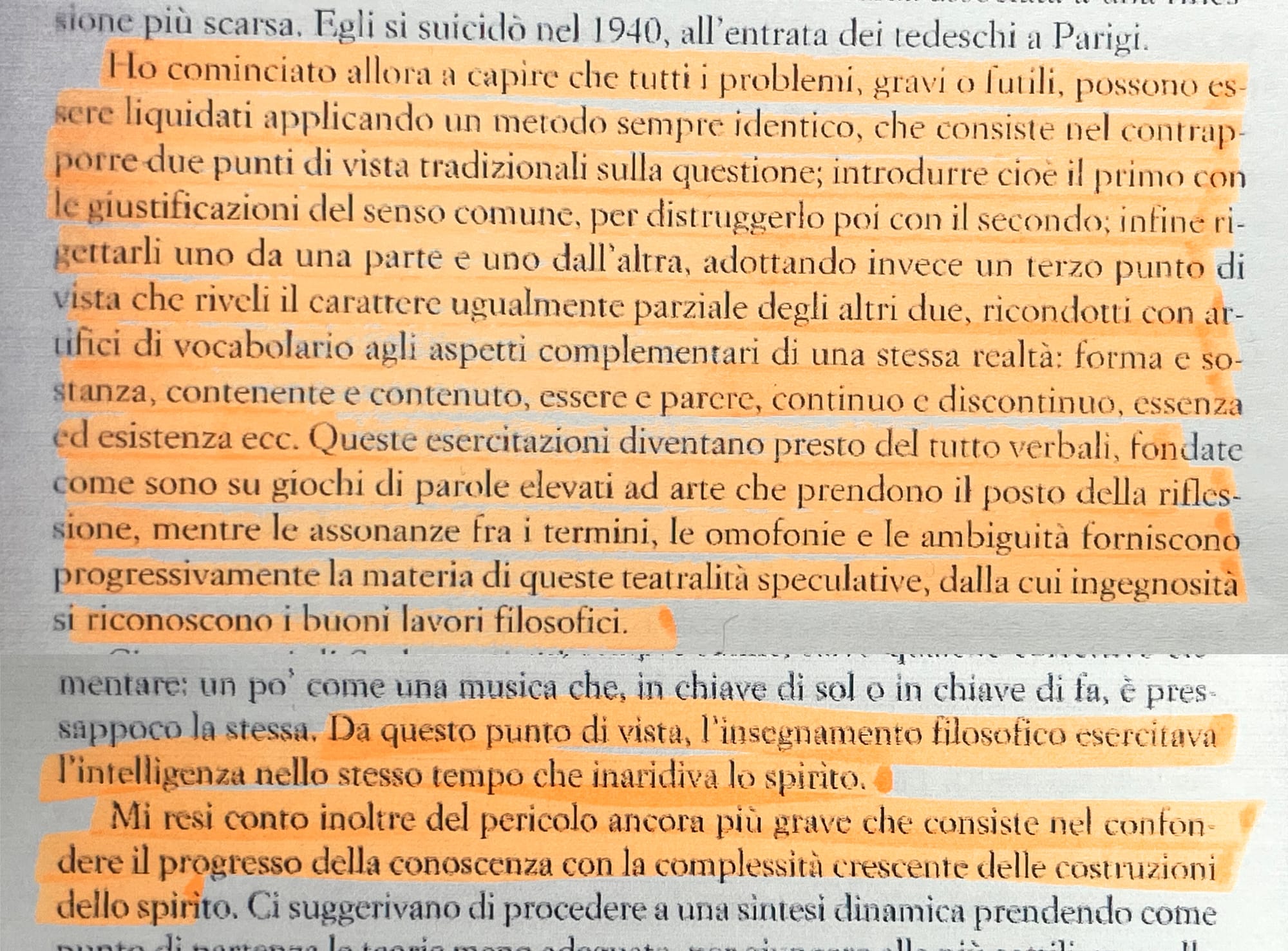
Le rappresentazioni non sono eterne, spesso diventano obsolete. I racconti visivi che costruiamo dipendono non solo dalla nostra sensibilità, ma anche dai tanti fattori socio-culturali in cui siamo immersi, e a molto altro. È davvero difficile trovare il “luogo” giusto da dove raccontare una storia, che sia sufficientemente vicino da poter catturare le sfumature, ma anche abbastanza distante da non suonare categorici e dispotici.
Quando mi accorgo che una rappresentazione visiva comincia a puzzare, come l’ospite sgradito dopo tre giorni, mi sale il prurito di prendere la macchina fotografica in mano per cercare qualcosa di diverso, che non è “quella-roba-lì-che-so-già”. Magari alla fine non combino niente, ma sento un po’ lo stesso la voglia di condividere con il mondo questa voglia di qualcosa di...nuovo. Di più fresco, giusto, equo, accurato...metteteci quello che volete.
È il languorino della madama in giallo: fame di qualcosa, ma non so bene cosa. Sono solo certa che non si tratta di tutto quello che ho già intorno.
Si comincia così a fare ricerche, a lavorarci, a parlarne e a produrre immagini finché, ad un certo punto, abbiamo tra le mani una nuova rappresentazione. Un po’ per il nostro impegno, un po’ per gioco e magia, la fotografia nuova ci appare (o ci avviene, come scriveva Barthes ne La camera chiara), bella e sgargiante, come la piramide dorata di Ferrero Rocher. Ci godiamo la nostra opera e tutti gli Ambrogio della nostra vita sono felici di non doverci più sentire rognare intorno a quello che non va in fotografia. Fine.
Abbiamo portato nel mondo qualcosa di buono. E così è, in effetti, se consideriamo il nostro lavoro su una linea progressiva, dove possiamo correggere, sostituire o integrare un immaginario obsoleto o deficitario con fotografie nuove, aggiornate e più dettagliate. Questo è un modo di vedere, e fare, le cose. Ma, come anticipavo, non è l’unico.
Le rappresentazioni sono oggetti di conoscenza. Sono forme all’interno delle quali raccogliamo un pezzo di mondo, cercando di dare un ordine, anche strampalato, ai suoi elementi. Da qui la macchina fotografica come strumento per esplorare la realtà e costruire un senso. Ma le nostre forme non sono dei contenitori a tenuta stagna, assomigliano più a degli scolapasta che si perdono per strada un sacco di succo. E, anzi, aggiungo di più: molta della sostanza si trova pure fuori dal mondo. Come fare per arrivarci?
E qui cerchiamo un altro approccio. Il mondo non può essere sottoposto solamente al regime delle rappresentazioni. Per spiegarci meglio: la fotografia che crea senso e conoscenza non basta. Il mondo non può essere limitato nelle immagini che possono essere spiegate, criticate e guardate da un pubblico.
Le rappresentazioni, se le prendiamo come veicoli di pensiero e comunicazione, sono come la piramide di Ferrero Rocher: un prodotto. Chi ci dice che domani, alla madama in giallo, non saranno venuti a noia anche i Rocher?
Fuori dalla finzione dello spot ogni prodotto diventa presto stantio, e va sostituito con un altro. Così come ogni rappresentazione che si presenta come nuova e risolutiva, per un discorso, diventa presto una gabbia che uccide ogni tipo di iniziativa pensiero. Le piramidi sono monumenti maestosi, ma anche tombe in cui si finiva murati vivi.
Cosa fare quindi?
Abbandonare le redini della conoscenza e lasciare spazio all’arte e alla poesia. E mi riferisco proprio a quell’arte di cui in fotografia a volte si parla con un po’ di imbarazzo, perché “faccio arte” sembra voler dire non far niente. E in un certo senso è così: si tratta di uno spazio in cui abbiamo il lusso di non fare niente al servizio del pensiero e della ragione (e dell’economia del produttivo e del mercato).
Potremmo quasi dire che questa prospettiva richiede un cambio di sguardo (modo d’essere) piuttosto che un cambio di rappresentazioni (oggetti). Come se la madama in giallo, invece di passare la sua esistenza in auto a cercare soddisfazione per i suoi languorini, si fiondasse fuori in mezzo al traffico, lasciando tutto ad Ambrogio, per andare chissà dove, senza alcuna spiegazione. Passerebbe per matta? Probabile. Ma dopotutto la pazzia è una di quelle cose del mondo che mina le fondamenta della conoscenza da secoli.

In uno dei suoi primi saggi, La nascita della tragedia, Nietzsche guarda all’Antica Grecia identificando due principi: il Dionisiaco e l’Apollineo. Apro parentesi: Nietzsche è sempre difficile da leggere, fa un po’ timore con quell’aria da vecchio austero e la fama di “ispiratore” del Nazismo (causati dal rimaneggiamento di alcuni suoi testi per mano della sorella e del cognato nell’ultimo periodo della sua vita e dopo la morte).
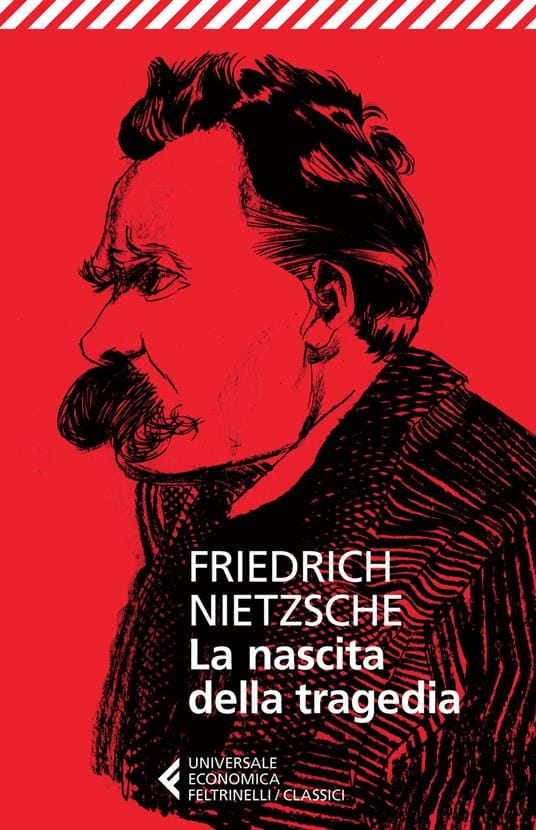
Ma sull’estetica e sull’arte, secondo me, ci ha preso alla grande. Vale la pena tirarlo fuori anche per la fotografia. Chiudo parentesi.
Dicevamo: Dionisiaco e Apollineo. Detta terra-terra, con il primo descriviamo il caos, il piacere orgiastico, e con il secondo la bellezza e la forma. Dionisio e Apollo non vanno visti come opposti in lotta, ma come divinità i cui poteri si intersecano e creano quella che è l’esperienza umana. L’origine di tutto è un principio unitario, un caos, una musica libera che non è inscrivibile in una sola forma, non si può conoscere come un oggetto. E su questo caos agisce il potere di Apollo generando, dall’uno, tante rappresentazioni. Tutte richiamano a quest’essenza che sta fuori dal mondo, ma nessuna può descriverla a pieno.
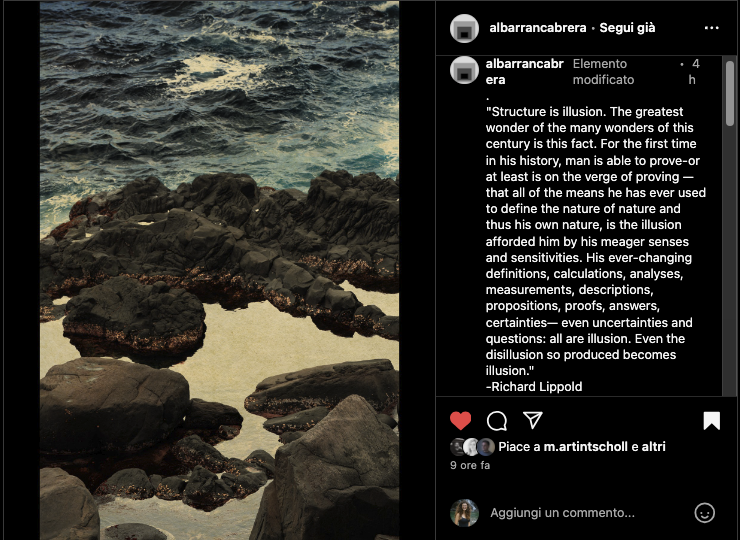
Nel testo Nietzsche parla molto di musica (tutto il saggio è legato allo sviluppo della tragedia greca), ma molto di quello che scrive può essere riletto in ambito fotografico.
«Perché la forma è bella? Perché - penso - ci aiuta ad affrontare la nostra paura peggiore, il timore che la vita non sia che caos e che la nostra sofferenza non abbia alcun senso.
[...]
William Carlos Williams diceva che i poeti scrivono per una sola ragione: dare testimonianza dello splendore [...]. È una parola utile, specie per il fotografo, perché riguarda la luce: una luce di irresistibile intensità. La forma a cui l’arte aspira è di una luminosità assoluta, ma è anche così intensa da non poter essere guardata direttamente. Siamo quindi costretti a intuirla dal riflesso frammentario che deposita sui nostri oggetti quotidiani: l’arte non potrà mai definire pienamente la luce.
[...]
L’arte semplifica. Non è mai esattamente uguale alla vita. Nelle arti visive, questa scelta attenta a favore dell’ordine è chiamata composizione, e molti artisti ne sono maestri». Robert Adams, La bellezza in fotografia. Saggi in difesa dei valori tradizionali.
Nel testo Nietzsche mostra di avercela a morte con Socrate (scherzo, ma nemmeno troppo) come colui che ha valorizzato la logica della causa e dell’effetto, il sapere e la conoscenza sopra ogni cosa, cieco da un occhio e con l’altro “in cui non ha mai arso la dolce follia dell’entusiasmo artistico”.
«Tuttavia la parola più sottile per questa nuova e inaudita sopravvalutazione del sapere e dell'intelligenza la disse Socrate, quando scoprì di essere l'unico a confessare a se stesso di non sapere niente; mentre invece, nel suo divagare critico attraverso Atene, interrogando i più grandi uomini di stato, retori, poeti, artisti, si imbatteva ovunque in una presunzione di sapere. Con stupefazione egli riconobbe che tutte quelle celebrità non avevano un'idea giusta e sicura neppure del loro lavoro e che lo eseguivano solo per istinto. “Solo per istinto”: con questa espressione tocchiamo il cuore e il centro della tendenza socratica. Con essa il socratismo condanna tanto l'arte quanto l'etica del presente: dove dirige i suoi sguardi inquisitori, egli vede la mancanza di intelligenza e la potenza dell'illusione, e conclude da tale mancanza l’intimo capovolgimento e l'inaccettabilità di ciò che esiste. Socrate credette di dover correggere l'esistenza a partire da questo unico punto: egli, il singolo, con espressione di disprezzo e di alterigia, in quanto precursore di una cultura, di un’arte e di una morale completamente diverse, irrompe in un mondo del quale noi considereremmo la più grande fortuna riuscire ad afferrare con venerazione un lembo.
[...] “la virtù è sapere; si pecca solo per ignoranza; il virtuoso è felice”: in queste tre forma fondamentali dell’ottimismo sta la morte della tragedia. Perché adesso l’eroe virtuoso deve essere dialettico, adesso deve esistere un legame necessario e visibile tra virtù e sapere, fede e morale». Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia.
Dopo l’avvento di Socrate la tragedia diventa un’opera, un prodotto di consumo, potremmo dire, da dare in pasto ad un pubblico educato e critico, assetato di conoscenza. Fare arte con questa predisposizione, per questo pubblico, non fa di noi solo dei cattivi poeti?
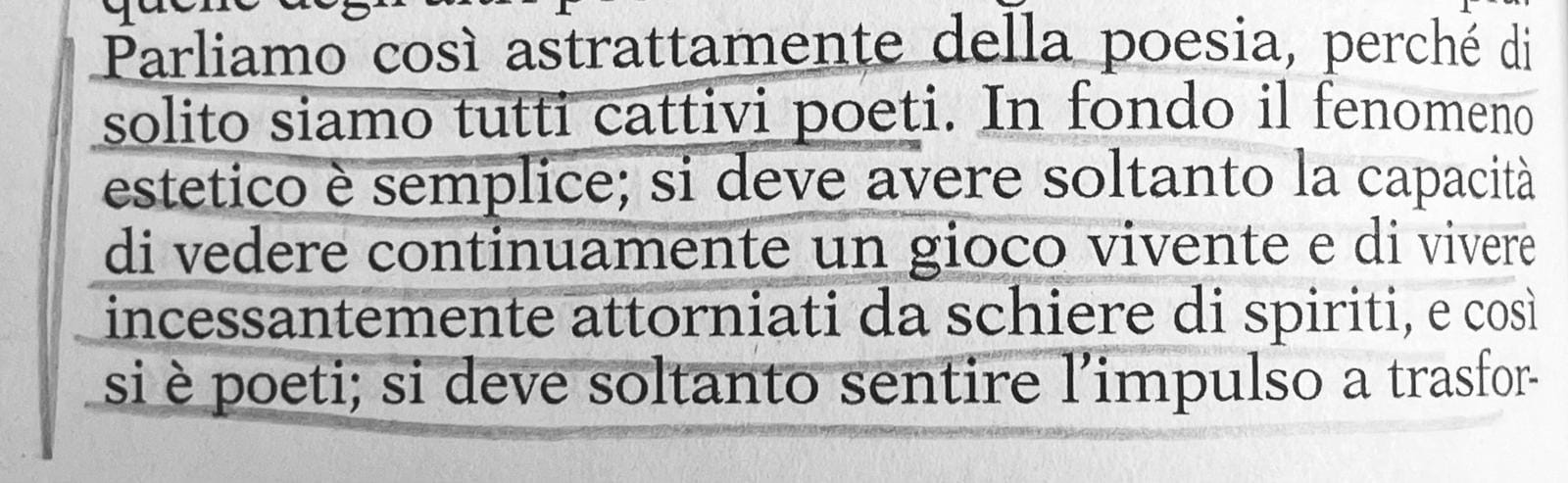
O, in altre parole, quando perdiamo la percezione dell’uno originale, del piacere, del tragico, non rischiamo di trovarci tra la mani solo tante forme vuote, tralasciando qualcosa per strada? A che punto le nostre fotografie perdono l’anima e diventano prodotti?
Intendiamoci, non dico di mettersi a fare cose a caso, perché “tanto tutto è caos”. Nemmeno Nietzsche lo sostiene: Dionisiaco e Apollineo, origine e rappresentazioni, musica e immaginario, viaggiano sempre insieme, non sono opposti che si combattono, ma principi che si mescolano. Che giocano.
«The human imagination has “something to do with our self-preservation” and helps us to live our lives”». Tim Carpenter, To Photograph is to Learn how to Die.

«I was filled with confidence that I would be able to enjoy taking fashion photographs, no matter how many I had to take, day after busy day. […] Every experience in those days was in the future tense. A literally endless sense of excitement filled the 1960s». Ikko Narahara, Ikko Narahara: Mirror of Space and Time.
Il punto da tenere qui, credo, sia proprio questo: non lasciarsi catturare dal confortante abbraccio delle certezze, dalla sicurezza che ad ogni languorino di qualcosa di nuovo ci apparirà Ambrogio con una piramide dorata di praline. Affrontiamo il vuoto, la tragedia: arriverà il giorno in cui i Ferrero Rocher finiranno. E comunque, appena arriva il caldo, d’estate, si sciolgono tutti e fanno schifo.
Ogni rappresentazione è solo un pezzetto di qualcosa che, forse, sta al di fuori del mondo. Che non possiamo osservare direttamente e fotografare come un prodotto, o un oggetto, come se la macchina fotografica fosse un microscopio. Solo uno strumento di conoscenza, appunto.
La fotografia può essere molto di più. In che modo, non lo so. Io, per intanto, mi sono messa a imparare a fotografare di nuovo come se dovessi partire da zero.

Forse bisogna solo seguire la musica.
«Quel logico dispotico aveva infatti talvolta la sensazione, di fronte all’arte, come di una lacuna, di un vuoto, di un mezzo rimprovero, forse di un dovere eluso. Spesso gli giunse in sogno, come egli narra in prigione ai suoi amici, una visione, sempre la solita, che gli ripeteva ogni volta: “Socrate, datti alla musica!”». Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia.
No spam, no sharing to third party. Only you and me.






